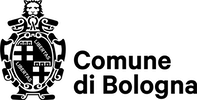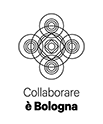Quando nel primo volume di quest’ opera e precisamente a pagina 83, indicammo ritenersi che nella casa posta in Azzo Gardino al N. 1232 (nota del Breventani: la citazione è vera, ma il numero della casa – orig. 1332 – è sbagliato. Si suppone il N. 1232. vedi correzione del Vol. I pag. 80). vi avesse abitato questo illustre nostro concittadino, non ci era venuto sotto mano un documento del Lancetti Vincenzo non posseduto dalle nostre Biblioteche di qui, che riguarda la vita del grande uomo e che ora diamo integralmente.
Delle tante obbligazioni che l’arte del guerreggiare moderno professa all’insigne capitano italiano Francesco de’ Marchi, somma e principalissima è quella de’ nuovi metodi di fortificazione da esso lui inventati, i quali hanno servito di modello agli edifici più celebri che in questo genere sono ora conosciuti in Europa. Poche ed imperfette notizie si hanno della vita di un uomo sì illustre, e queste non da altra fonte possono per lo più ricavarsi che dai preziosi suoi libri dell’ Architettura militare. Io di là le trassi fin dal 1809, come potrei ampiamente provare, cioè tre anni allo Incirca avanti che il signor Marini pubblicasse in Roma con tanto suo onore la nuova magnifica edizione dei suddetti libri: di là le trasse il signor Marini medesimo, e di là pure il chiarissimo signor conte Fantuzzi, che ne parla nel tomo V delle sue Notizie sugli scrittori bolognesi. Compendiamo perciò le cose già da me disposte nella mia storia della letteratura militare, alla quale da più anni (per quanto i miei doveri e la salute mia lo permettono) vado applicandomi, le poche cose che di questo insigne scrittore ho potuto raccogliere e congetturare esporrò con semplice narrazione e senza veruna pompa di elogio.
Da Marco de’ Marchi, ccrne prova il Fantuzzi, e non da Bartolommeo, come pretese il sig. Corazzi nel suo libro Intitolato l’Architettura militare di Francesco Marchi citladino bolognese e gentiluomo romano difesa dalla critica del sig. Allano Manesson Mallet parigino, nacque il nostro Francesco ìn Bologna, ove la sua famiglia, oriunda di Crema, erasi già da un secolo stabilita. I due sopraccitati scrittori pensano che la nascita di Francesco avvenisse verso la fine del 1506, o al principio del 1507; ma io tengo per fermo che debba riportarsi dieci anni più addietro, cioè sul finire del 1495 per le ragioni che addurrò, ove dell’epoca della sua morte mi converrà favellare.
Nulla sappiamo de’ primi studi di Francesco, se non che una inclinazione invincibile lo spinse allo studio dell’architettura, nella quale sino all’età sua più fresca ambiva di riuscir eccellente. Cominciai questa mia dilettazione, dic’egli nel cap. 36 del libro II, in età giovanile, e non ho mai cessato d immaginarmi cosa per la quale io dovessi essere onorato, e che ponendola in esecuzione dovesse la fabbrica riuscire con gloria e fama perpetua. La militare architettura divenne assai presto lo studio suo favorito, né a miglior partito poteva egli appigliarsi per giungere ad alta fama, essendo essa a que’ tempi burrascosi quanto utile altrettanto mal conosciuta.
Egli è probabile che ne acquistasse rapidamente gran credito, giusta il suo desiderio; imperocché trovasi ch’ei passò al servizio di Alessandro de’ Medici nipote di Clemente VII, che primo nel 1531 regnò in Toscana con titolo di duca. E perchè a nuovo principe è necessaria ogni sorta di presidio, così una fortezza fece egli innalzare in Firenze, ed una in Pistoia, onde por freno ad un popolo cui poc’ anzi eransi tolte le armi e la libertà. È da credersi che del primo edifizio venisse incaricato il de’ Marchi, sì perchè trovavasi al servizio del duca, come perchè ne godeva sicuramente la grazia. Che il fosse del secondo è certissimo perchè se ne ha la stessa sua testimonianza citata dal Fantuzzi nella nota 5 della faccia 220 del tom. V con parole tratte da un suo manoscritto. Di questi suoi primi servigi si ha pure memoria al capo 82 del libro II della suaArchitettura militare, in cui racconta di un uomo annegatosi in Arno in tempo del duca Alessandro de’ Medici, che era mio padrone.
Prova dell’alta stima in cui salì nella corte Toscana si è lo avere nel 1535 accompagnato a Napoli lo stesso duca, il quale con solenne pompa andò ad iscolparsi presso l’ imperadore Carlo V delle imputazioni fattegli da’ fuorusciti fiorentini, de’ quali era capo Filppo Strozzi, e ad isposarsi con Margherita d’ Austria , figliuola naturale dell’ imperadore. E siccome quelle nozze vennero celebrate sfarzosamente nel dì ultimo dì febbraio del 1536, e il duca di là a pochi giorni tornossene lieto a Firenze, così è facile che il de’ Marchi si approfittasse del tempo per esaminare le spiagge e luoghi fortificati del Regno, dappoiché in diversi capitoli dell’opera sua ne parla, e retrocedesse di poi col suo duca in Toscana, ovveramente con la duchessa, la quale entrò in Firenze il giorno ultimo di maggio. Questo suo viaggio si desume eziandio dalla relazione che lo stesso de’ Marchi pubblicò molti anni dopo sulle feste celebrate per le nozze del glorioso principe Alessandro Farnese figliuolo di Margherita, e protettor suo quanto lo fu la madre.
Nella notte del 6 di gennaio 1537 il duca Alessandro venne ucciso dal cugin suo Lorenzino. Cosimo gli succedette qual capo e governatore della Repubblica Fiorentina.
Ma Alessandro Vitelli che era capitano delle milizie ducali impadronitosi scaltramente della fortezza, scrisse all’ Imperadore che l’avrebbe tenuta a sua disposizione. In essa rifuggissi Margherita allora giovinetta di 15 anni, la qual poscia passò a Prato, indi a Pisa per attendere gli ordini dell’augusto suo padre. Aspirava Cosimo alla di lei mano, ma l’accorto pontefice Paolo III la ottenne dall’ Imperadore per Ottavio Farnese suo nipote, fìglio di Pier Luigi allora duca di Castro, che in questa occasione fu da Cesare investito del marchesato di Navara. Ad Ottavio, che era Prefetto di Roma , conquistò poi il Pontefice il ducato di Camerino. Margherita entrò in Roma il giorno 3 di novembre 1538, e le nozze vi si celebrarono con papale splendidezza. Probabilmente il de’ Marchi rimase sempre addetto e fedele al di lei seguito , imperocché trovasi ch’ egli era confidente di Paolo Vitelli figliuol di Alessandro, che passò al servizio della casa Farnese, e che Margherita l’ebbe ognora con sè.
In questi giorni il Pontefice ricordevole dell’assedio delle truppe Alemanne al castello s. Angelo, cui fu esposto nel 1527 Clemente VII, ed al terribile saccheggio cui fu la città per ben tre giorni lasciata in preda, ordinò che Roma si fortificasse per modo, che più non avesse a trovarsi in simili strette , e ne diede il carico a Giovanni da san Gallo illustre architetto Quando i lavori eran di molto avanzati, elesse una commissione ad esaminarli , e il nostro de’ Marchi fu chiamato ad esserne membro. Il de’ Marchi, che alla scienza delle fortificazioni quella delle artiglierie riuniva , disapprovò la costruzione di un baluardo che giudicò si povero di spalle da non poter opporre veruna resistenza alla forza del cannone. La controversia che quindi ne nacque è inutile di qui descrivere, tanto più che il sig. Marini l’ha egregiamente illustrata ne’ suoi prolegomeni all’ opera del nostro autore. Debb’ essere in questa occasione ch’ egli venne decorato della cittadinanza di Roma, qualità di cui si pregiò sempre di poi, e che appose costantemente al suo nome, chiamandosi bolognese , gentiluomo ( o cittadino romano ). Ond’è che alcuni il credettero romano di patria, ira i quali il chiarissimo Papacino d’Antoni nella sua prefazione alla Archittetura militare.
In questa occasione parimente, cioè dall’anno 1539 sino al 1545, fu adoperato intorno alle fortificazioni di Camerino, Castro e Nepi, non che di Pesaro, che le armi pontificie avevano a quei dì occupato. Ma fu soprattutto in questo stesso intervallo ch’ egli pose mano alla sua grand’ opera dell’ Archittetura militare, e cominciò a disporne i disegni e probabilmente a darne contezza agli amici , prima ancora di averli pubblicati. Imperocché nella introduzione al lib. III egli narra, che la maggior parte della sua opera era in ordine nel 1545, siccome potete veder qui esaminando le mie scritture, essendo in Roma in tempo di papa Paolo III, e cita in testimoni lo spagnuolo Salamanca stampatore in figure e in lettere in Roma, et Antonio Lauteriero Borgognone medesimamente stampatore in Roma, co’ quali per avventura aveva preso a contrattare per la impressione de’ suoi disegni. Nella stessa introduzione protestasi di nulla avere ad altri defraudato, ma anzi alcuni defraudato a me alcuni miei disegni con diminuire e aggiungere d’ogni poca cosa, e d’essi si sono fatti cavalieri d’esser stati toro gl’ inventori (fol. 44 tergo); e segue dicendo di aver conferito con parecchi amici, e regalatili de’ suoi disegni , li quali son pervenuti alle mani di valenti disegnatori e essi gli hanno ritirati assai bene. Ciò debb’ essergli sicuramente accaduto a Roma, e codesti defraudatori debbono probabilmente essere stati quei tali Castrioto, Leonardo da Udine e Galasso da Carpi, che in materia di fortificazione divulgaron di poi libri e disegni accreditati.
Nel 1545 la casa Farnese ebbe da Papa Paolo III i ducati di Piacenza e di Parma. Del primo fu investito Pier Luigi, e del secondo Ottavio suo figlio. Rimasto era il de’ Marchi al servizio di Margherita, e per conseguenza passato a quello del di lei sposo Ottavio: ond’ è ch’egli tenne dietro al suo nuovo padrone in Parma, ove fu tosto adoperato tanto nel fatto delle fortificazioni, come in quello delle artiglierie. Imperocché Ottavio anch’esso era uomo di guerra, e nel 1546 fu generale in capo dell’esercito Pontificio spedito contro gli Ugonotti. Dai discorsi 34, 99 e 121 del libro III rilevasi che il de’ Marchi possedeva in Parma il carico di Commissario del cannone, come lo chiama il P. Corazzi, cioè di direttore delle fonderie, e comandante delle artiglierie, come ora direbbesi. La morte violenta di Pier Luigi avvenuta nel 1547, l’occupazione di Piacenza fatta a nome dell’ imperadore da Ferrante Gonzaga allora governatore di Milano, e il pericolo che Parma incorresse nella medesima sorte indussero il Papa a richiamarne tostamente il nipote , a riunirne il ducato alla camera apostolica, ed a mandarvi nel 1549 Cammillo Orsino per custodirlo, Questo generale non volle poi restituirlo ad Ottavio nè quando vi ritornò senza assenso del Papa, nè quando il Papa lo impose pria di morire. È probabile che il de’ Marchi sempre fedele al suo principe rimanesse ognora al suo seguilo in mezzo a codesti turbamenti.
Morto Paolo III il giorno 10 novembre 1549, gli succedette Giulio III, il quale confermò ad Ottavio il grado di gonfaloniere della Chiesa, e il ducato di Parma, che finalmente gli venne reso il 24 febbraio 1550. Il sospetto che Carlo V volesse il dominio di questo ducato, come aveva quel di Piacenza, i mali uffizi di Ferrante, e forse alcun’ altra segreta cagione sfuggita agli storici indussero Ottavio a separarsi dal partito dell’ imperadore e quello seguir de’ francesi. Vendicossene Carlo togliendogli Novara e il ducato Cività di Penna, beni dotali di Margherita, e ordinando al Gonzaga d’investir Parma, la quale si trovò assediata ne’ giugno del 1551 dalle truppe tedesche, e poco dopo anche da quelle speditevi dal Pontefice alleato di Carlo. Allora fu che il nostro valoroso de’ Marchi ebbe occasione di servir il signor suo con quell’ardore e con quella abilità che gli era si propria traendo profitto da ogni circostanza. Nel capitolo 33 racconta di aver fatto spianare la punta al baluardo di Federico in Parma in tempo ch’ ella era assediata ; nel cap. 41, e nel discorso 124 descrive i vantaggi che gli assediati traevano dall’ ingrossamento de’ torrenti e de’ fiumi, e dice che ad onta di tanti soldati e presidi positivi intorno, ogni volta che ingrossavano detti fiumi noi uscivamo fuori a quella parte ci pareva a pigliare vittovarie e soccorsi; nella pianta xxix indica le fortificazioni erettevi, e meglio nella lxxviii, e ne fa parimenti ricordo nelle piante xxxii c xxxix. Non so come il Fantuzzi contro l’esposizione del suo illustre concittadino che vi ebbe tanta parte, e che ne scrisse cosi positivamente, osasse dire che di quest’assedio non vi è autore che ne faccia parola, e ne redarguisse il P. Corazzi, come se questi e non il de’ Marchi ne avesse parlato. Sol ch’ egli avesse consultato gli storici contemporanei egli se ne sarebbe chiarito. Di fatto se ne disdisse di poi nelle correzioni ed aggiunte fatte alla sua opera. Ma il Fantuzzi fa pur dire al Corazzi che il duca Pier Luigi si valesse di de’ Marchi per far fabbricare la fortezza di Piacenza, cosa che il Corazzi non ha mai detto in nessuna parte del suo libro: a meno che il biografo bolognese non intenda parlare del palazzo di Piacenza detto la cittadella, il quale è diverso edifìzio dalla fortezza, e che rimase a mezzo per la morte di chi lo faceva innalzare. Ma in tal caso doveva il Fantuzzi non ignorare che anche questa osservazione non è dal Corazzi immaginata a capriccio, ma tolta da quanto dice il de’ Marchi stesso, nel capitolo 62 del secondo suo libro, ove racconta ch’ ei fu commissario soprastante alla fabbrica di quel palazzo. Quel grandioso edificio dovette aver principio appena che Pier Luigi andò duca a Piacenza, cioè nel 1545, ed essere sul finire dal seguente anno sufficiente all’ alloggio del principe , sebbene appena ne fosse fatta la metà, giacché nel 1547 Pier Luigi vi abitava di certi, e da un balcone di esso ne venne, come ognun sa, gittato dai congiurati il cadavere.
Preceduto ed accompagnato da una già splendida reputazione trasferissi il nostro scrittore da Parma alle Fiandre insieme alla sua protettrice Margherita d’Austria, che Filippo II di Spagna avea chiamato a governarle. Ciò accadde nel 1559. Poi fu nominato ingegnere e capitano al servizio del Re, impiegato in molti importanti lavori , e vantaggiosamente conosciuto e tenuto caro dai grandi, che comandavano gli eserciti di Filippo, o che ne erano ministri. Debbon tra questi distinguersi i signori componenti il supremo consiglio di Fiandra, che spesso io invitavano a trovare e suggerir nuovi modi di fortificare, e seco lui volentieri ne ragionavano. Troviam diffatto nella sua grand’ opera diretta al conte di Egmont (o di Agamonte com’ei lo chiama) il discorso 142, al conte de Horn (o di Orno) il discorso 144 il 145 al conte di Mansfelt, al principe di Orango il discorso 157, e a tutti insieme il discorso 150. Forse militava a quei di nelle Fiandre anche il celebre Paolo Vitelli, al quale è rivolto il discorso 159, e Francesco Lonisino cui indirizzò il discorso 132, e l’uomo di guerra Maria Cardonino cavaliere napolitano, a richiesta del quale il de’ Marchi racconta di aver fatto il disegno , o pianta 195. Sopra lutti però venerava egli ed onorava il principe Alessandro Farnese , e come figlio della sua benefattrice, e forse come suo allievo nelle matematiche militari, e sicuramente come ammiratore di quel genio, che andava in lui sviluppandosi rapidamente, e che presto lo rese il maggior capitano del suo secolo.
Cosi alte aderenze e protezioni, ed un si chiaro merito dovettero porre il de’ Marchi nella situazione di venir consultato in tutti i lavori di fortificazione che a que’ tempi ed in que’ luoghi occorrevano, e di esserne principalmente incaricato, come colui che ne’ era il gran maestro; ed io son persuaso, che il Belgio a lui debba molte di quelle dighe, e di quelle fortezze, per cui potè resistere alla forza dell’oceano ed all’impeto dì tanti nemici, e salire in gran rinomanza. La storia non ce ne ha lasciato verun monumento, o forse lo ha distrutto l’invidia; ma noi sappiamo da lui medesimo che nel 1563 egli trovossi a Malines nella qualità di ingegnere del Re, e nel discorso 108 fa cenno delle riparazioni che si andavano allora opponendo in Zelanda ed in Olanda alle esuberanti acque del mare, e delle munizioni di Anversa, che quarantotto anni innanzi non era nulla, e fu poscia sì valido baloardo in occasione degli attacchi sostenutivi dal Farnese.
Nel 1565 accaddero le nozze del principe Alessandro Farnese con donna Maria figlia di Odoardo fratello di Giovanni re di Portogallo, e il nostro autore , che affezionatissimo gli era, raccolse e descrisse in una sua Relazione, che fece stampare il seguente anno in Bologna sua patria, tutte le magnificenze ed allegrie che un sì lieto avvenimento produsse. In codesta occasione la protettrice Augusta di de’ Marchi comparve in cocchi di nuova foggia, che l’ingegnoso architetto aveva egli stesso inventato e fatto eseguire. Tra gli epitalami, che vennero allora pubblicati in Anversa con le nitide stampe dj Plantino, uno ve ne ha di Pietro Mamerano, del quale mi giova qui trascrivere alcuni versi, perchè dovrò a suo luogo ricordarli in proposito degli anni vissuti dal de’ Marchi. Il poeta parla dell’inventore di que’ cocchi:
……………….
Is tenet a Marca Franciscus nomen, avitis
Qui sua deduxit stemmata clara viris
……………….
Vir propter seram venerandus ubique senectam
Aetate atque gravis, Consilio atque gravis:
Vir cui et ingenii largitrix Itala tellus,
Vix dedit injenio judicioque parem. ec.
Ma inferocendo ogni di più la civil guerra, e la gloriosa resistenza de’ Batavi, condotti dal gran Maurizio, opponendo ostinata repulsa alle forze di Filippo, parve a questo Re di travedere nel supremo consiglio di Fiandra una segreta intelligenza co’ nemici, ed in Margherita sua sorella una insofficiente capacità al governo, al quale perciò elesse, lei dispensandone, il troppo noto per le sue crudeltà duca di Alba. Ritornò Margherita in Italia al principio del 1568. Cosa avvenisse del nostro De’ Marchi in mezzo a tanti scompigli, vendette e tumulti è del tutto ignoto, siccome è ignoto il luogo e il tempo della sua morte. In mezzo a sì denso buio io ho tentato di raccogliere un fil di luce, che a probabili congetture mi servisse di guida.
Era egli il de’ Marchi partito per l’Italia avanti che Margherita vi retrocedesse, ovveramente vi tornò egli con essa, o rimase in Fiandra? Nessuna plausibil ragione vi ha per crederlo venuto in Italia prima della sua protettrice, anzi ve ne hanno di opposte. Quanto all’ esservi con lei ritornato, certo è che la partenza della sua antica padrona, la sicurezza di continuar ne’ servigi del duca Ottavio, il natural desiderio della patria, l’amore della propria sua fama depositata ne’ disegni, forse già tutti da lui mededesimo incisi, e ne’ manoscritti costituenti la sua grand’ opera, i quali potevano in paese straniero, in caso di sua malattia, andar dispersi, o essere involati: la invidia, e per avventura il sospetto, cui troverebbesi esposto nella corte del duca d’ Alba , si perchè amico dei processanti conti di Egmont e di Horn, come per lo stesso straordinario suo merito: e il nessun monumento di lui rimasto in quelle contrade, sono a parer mio altrettanti argomenti, che rendono probabile il di lui ritorno con Margherita, che già lo avea quivi condotto. Ma l’esser egli assai vecchio e probabilmente rifinito di forze: lo aver forse vicino il proprio figlio: l’esser fors’anco stimato e adoperato dal duca d’Alba, il qual volle tosto innalzare in Anversa una fortezza con cinque baluardi reali , giusta la prima idea di Margherita; e per conseguenza giusta i disegni del nostro autore , che il celebre Paciotto da Urbino in questa occasione pose in opera: il poter anche esserne considerato nemico, attese le antiche sue aderenze col principe di Orange e con gli altri imputati personaggi: tutto ciò’ può far congetturare, che egli in Fiandra vi rimanesse, ed ivi i suoi giorni finisse, o per infermità, o per violenza, giacché il duca vi fece man bassa sopra più di 600 distinte persone, prese in sospetto di delitti di ribellione o di eretical gravità.
Che il de’ Marchi nel partirsi d’Italia lasciasse in Bologna un suo figliuol naturale, e che questi si chiamasse Marco Antonio, rilevasi tanto da una lettera del padre stesso, che il dottissimo signor Luigi Marini ha riportato nella magnifica sua edizione, quanto da una di Giulio Poggiano , che anche il Fantuzzi ha riferito. La prima, che è data in Anversa il giorno 11 maggio 1567 diretta al cardinal Farnese, ci istruisce che la corte di Roma aveva accordata la leggittimazione di Marco , il qual mancava in Bologna de’ soccorsi necessari per continuar ne’ suoi studi, ond’ è che il padre pregava l’eminentissimo di provvedervelo. Pare che questo favore non ottenesse, e che perciò il figlio si risolvesse di recarsi in Fiandra egli pure, e venisse dal Cardinale Bonelli, detto l’Alessandrino, munito di lettera commendatizia diretta all’arcivescovo di Cambrai, ed al Vescovo di Liegi, acciò lo assistessero conferendogli alcun benefizio ecclesiastico, di che avrebbe avuto loro grand’ obbligo, dice la lettera, anche il Capitano Francesco suo padre huomo onorato et di valore, il quale si trova al presente al servizio di madama la Reggente. Questa è la lettera del Poggiano sopraccitato, il quale dell’Alessandro era segretario, ed è data a Roma il giorno 8 di ottobre dello stesso anno 1567. Io inclino a credere, che Marc’ Antonio de’ Marchi, che a quell’epoca doveva avere circa 24 anni di età, spinto dalla miseria, scortato dalla commendatizia del cardinale Bonelli, lusingato dagli inviti e dalla situazione del padre, si conducesse nelle Fiandre presso di lui, e seco rimanesse fino che ne ebbe raccolti in Anversa o in Brusselles gli ultimi aneliti, e le preziose sue carte, e che ricco di tanto tesoro, e raccomandato forse dal gran capitano Alessandro Farnese, ripassasse in Italia, e venisse preso al servizio del duca Ottavio , cui la memoria di Francesco de’ Marchi doveva essere carissima. Un Carmen encomiastico del P. Jacopo da Messina composto per la restituzione della fortezza di Piacenza fatta nel 1585 da Filippo II al duca suo cognato, ed ivi impresso nel medesimo anno, vedesi preceduto da una lettera di esso Marc’ Antonio, in fin della quale leggesi : Dat. Placentiae ex Ducali palatio quarto nonas julii 1585. Ma nulla in essa è detto del padre suo, e questo silenzio del figlio rispetto ad un uomo si benemerito dalla casa Farnese è per me un argomento assai sufficente per crederlo a quell’epoca estinto.
Tuttavia si è dal Fantuzzi e da altri costantemente creduto che il capitano de’ Marchi morisse verso la fine del 1597 per due principali ragioni; la prima perchè l’ultima pianta o disegno, che trovasi in tutti i perfetti esemplari dell’ Architettura militare del nostro autore, porta la data dell’anno 1597, cosicché sembra a que’ biografi che, come esso coll’anno 1545 segnò la data del suo primo disegno, cosi col 1597 avesse voluto segnare il termine del suo grandioso lavoro. La seconda ragione procede dall’avere il dall’ Oglio primo editore dell’opera di de’ Marchi nella sua dedica al duca Gonzaga premessa alla edizione del 1599 detto che tre anni innanzi gli aveva presentata questa grand’opera lasciata già in istampa di rame, ed ora ne presenta le dichiarazioni.
È vero che il disegno soprallegato porta la data del 1597, ed è pur vero che la medaglia e la inscrizione fatte in onor del de’ Marchi, delle quali farem cenno tra poco, gli attribuiscono 91 anno di vita, la qual cosa ammettendo, ei sarebbe didatti morto nel 1597 se nato fosse nel 1506. Ma chi assicura che la data incisa su quel disegno vi fosse apposta dal de’ Marchi? Qual prova si ha che morisse di 91 anno? e quale ch’ ei nascesse nel 1506? Imperocchè ciò che della sua nascita asserisce il P. Corazzi è interamente smentito dalle giuste osservazioni del Fantuzzi. Può a queste aggiungersi che se il de’ Marchi fosse nato nel 1506, egli avrebbe avuto 59 anni quando nel 1565 avvennero le nozze di Alessandro Farnese, e il Mamerano non gli avrebbe applicata quella seram senectam dell’ undecimo verso del suo epitalamio, del quale si è di sopra citato un frammento. E se nel 1597 fosse stato ancor vivo, perchè il dall’ Oglio non ne fece pur motto nella sua dedicatoria ? E come avrebbe egli potuto circa tre anni prima della edizione del 1599 presentare al duca Gonzaga le stampe in rame di quella grand’ opera , se l’autor di essa era tuttavia vivente? fino a tanto ch’io non conosca miglior monumento che assicuri l’epoca della nascita del de’ Marchi, mi sarà lecito di rimanermi nella opinion mia ch’egli nascesse verso il 1495, che perciò nel 1565 toccasse la seram senectam attribuitagli dal Mamerano, e che nel 1585 fosse già morto; altrimenti il figlio suo non sarebbe stato a que’ giorni in Piacenza, ma nel Belgio, per le ragioni sopra allegate, ovvero s’egli era a Piacenza e che il padre suo tuttora vivesse ne avrebbe senza meno fatto ricordanza nella lettera precedente il Carmen già menzionato. Potrebbe credersi che fosse divenuto equivoco nell’incidere le cifre dell’anno 1597, e che in luogo della cifra 9 dovesse intendervisi la cifra 6, che è il 9 rovesciato. Forse per ciò il dottissimo signor Marini scrive essere sua opinione che il de’ Marchi cessasse di vivere nel 1567, o in quel torno. Ma trattandosi di congetture più o meno probabili io confesso che non so dipartirmi dal pensier mio, ch’ ei vivesse fin verso il 1580; di che. come di altri punti storici relativi alla grande sua opera, verrà più lungamente trattato nella mia Storia della letteratura militare.
Nessun monumento d’onoro innalzò la patria ad uomo, che è il creatore delle moderne fortificazioni. Ma questa disgrazia è a lui comune con altri grand’ uomini d’ Italia. Soltanto nel 1765 il senato di Bologna fece coniare da Filippo Balugani una medaglia colla effigie del de’ Marchi dà un lato, ed una Pallade in mezzo a diversi militari emblemi dall’altri Iato. Essa venne poi incisa in rame dal celebre Rosaspina nel 1787. Codesta effigie fu tratta da quella che trovasi nella rarissima edizione delle prime tavole, o disegni, che in numero di xxxi lo stesso de’ Marchi divulgò, e di lì pure la trasse il signor Pietro Fontana, la cu incisione è posta in fronte ai prolegomeni della nuova edizione di Roma. I signori Calzoni di Bologna, nella madre de’ quali, che fu Lucrezia de’ Marchi, si estinse la famiglia del nostro insigne architetto, posero nel 1786 in onor suo nella chiesa de’ conventuali una iscrizione, che migliorata di poi nel 1794 e sottoposta alla effigie di si grand’uomo egregiamente eseguita in basso rilievo da Giovanni Tassoni scultore Bolognese, venne trasportata nelle stanze dell’Istituto ora Universiaà, di Bologna, ove è degnamente locata.
Ma la quantità e l’eccellenza delle invenzioni fortificatorie del De’ Marchi, il profitto e l’uso fattone dai più classici architetti militari d’ogni nazione, l’estrema rarità e carezza tanto de’ primi disegni da lui pubblicati senza le dichiarazioni, come della edizione compiuta fattane dal dall’ Oglio nel 1500, e la ristampa magnifica testé fattane a Roma mercè la munificenza di splendido e coltissimo mecenate (il signor duca di Lodi,) con aggiustatissime illustrazioni e correzioni del signor ingegnere Luigi Marini;, uomo di questa scienza ed in più rami di buona letteratura versatissimo, assicurano al capitano Francesco de’ Marchi la più gloriosa immortalità.