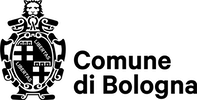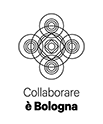La più antica fabbrica bolognese ?
Da collegio a fabbrica dei panni di lana: un edificio dimenticato in via del Porto.
GIANCARLO DALLE DONNE, archivista e ricercatore storico.
Un edificio “scomparso”
In seguito all’attuazione del piano regolatore del 1889 tutta l’area intorno al porto di Bologna e al Canale Cavaticcio cambiò aspetto. Per quasi quattro secoli era stata caratterizzata dalla presenza di insediamenti protoindustriali, mulini, filatoi, cartiere, che sfruttavano l’energia idraulica fornita dai canali.
Si agì in due direzioni. In un primo momento, seguendo le indicazioni del Piano di Risanamento, espropriando e demolendo gli antichi edifici che si affacciavano su via S. Bernardino, adibiti ad abitazioni, botteghe, pile da riso, cartiere, forni da pane, fu possibile creare una grande arteria, denominata Via Principe Amedeo, poi Via Roma (il tratto finale dell’attuale Via Marconi) in grado di collegare agevolmente Via Riva di Reno con Via del Porto,
Successivamente, l’intervento riguardò l’area intorno al vecchio porto: “tutti gli edifici subirono il processo di decadenza della struttura portuale iniziato con l’avvento della ferrovia, sopravvissero fino al 1934, quando le trasformazioni urbanistiche dovute alla realizzazione della piazza dei Martiri e della via Don Minzoni e l’ampliamento dei viali di circonvallazione cancellarono definitivamente l’impianto del vecchio porto. La darsena fu tombata, ma tuttora esiste sotto il piano stradale, la Dogana e tutti gli edifici addossati alle mura furono demoliti; l’osteria scomparve con gli eventi bellici della seconda guerra mondiale.L’unico edificio sopravvissuto è la Salara, il grande magazzino di sale e granaio” (Nannelli).
Al confine tra le due zone (S. Bernardino e intorno al porto) sorgeva un imponente palazzo, con alle spalle una lunga storia e una doppia vocazione: dapprima sede dell’Accademia degli Ardenti, un Collegio per nobili, lì trasferitosi nel 1586, con all’interno anche un importante teatro; successivamente, dal 1734, sede di attività produttive, legate al settore della lana.
Il palazzo oggetto di questo studio originariamente era proprietà della nobile famiglia Torfanini, poi, dal 1651, dell’Accademia del Porto, del mercante Francesco Boschi dal 1742, dell’imprenditore Luigi Pasquini a partire dal 1848. Quando, nel 1737, l’Accademia considerò la possibilità di vendere l’edificio, cosa effettivamente avvenuta nel 1742, il Senato Bolognese se ne interessò per un possibile acquisto richiedendo all’architetto Carlo Francesco Dotti una perizia ed un preventivo “relativi alla costruzione di un granaio pubblico”.
Quell’edifico che, anche in autorevoli pubblicazioni, è stato considerato “opera distrutta” di cui “oggi non si ha più traccia del fabbricato” (Matteucci), si trova in via del Porto 30, quasi all’incrocio con l’attuale via Marconi. Il palazzo, ristrutturato in profondità agi inizi degli anni Ottanta del Novecento, ancora nel 1973 era sede di attività produttiva, ospitando la fabbrica A.M.B.A. (Anonima Manifattura Biancheria ed Affini), poi la Marvel. Ma ha ospitato, soprattutto, quella che può essere considerata la più antica fabbrica – nell’accezione moderna – di Bologna, fondata nel 1734 dal mercante Francesco Boschi, in seguito, fino al 1878, sede del lanificio Pasquini.
Il Collegio del Porto.
L’Accademia degli Ardenti, fondata nel 1555 dal senatore Camillo Paleotti, era un collegio dove venivano iniziati alle belle arti i fanciulli della nobiltà bolognese.
La prima sede era in Via de’ Vinazzi, e successivamente, dal 1586, “in strada de’ Morelli [o Via del Porto] nn. 1005-1009”, dove l’Accademia affittò, e nel 1651 acquistò, un grande palazzo proveniente dall’eredità Torfanini, che prese il nome di Accademia (o Collegio) del Porto.
Il Collegio era guidato da dodici nobili delle più illustri famiglie bolognesi. Vi si insegnavano grammatica, latino, greco, storia, geografia, poesia, scrittura, disegno, musica, canto, danza, ma anche esercizi ginnici e d’armi e giochi di società.
Nel 1692 fu affittato ai Padri Somaschi, che alcuni anni dopo ristrutturarono l’edificio. Risultava essere costituito dagli ambienti per ospitare i convittori e i direttori, refettori, cappellina, porticato della cavallerizza, granaio, conserva. Nel 1703 venne costruito il “superbissimo teatro dipinto dal famoso Francesco Bibiena”, il quale “aveva realizzato una scena fissa simile al teatrino di corte a Parma, un magnifico loggiato a due ordini aperto verso fondali di paesaggio: un primo piano delimitato da una inquadratura rigida e squadrata, un secondo piano semicircolare raccolto dal giro del prospetto per angolo. Nel grande loggiato a due ordini il gioco delle fughe prospettiche puntava sull’effetto a giorno delle architetture, le quali si stagliavano contro un fondale di cielo aperto” (Tomasina, 2010).
La gestione dei Padri Somaschi si concluse nel 1733, in seguito a dissesto finanziario. Da quel momento la storia dell’edificio cambiò decisamente verso.
Rinascita di un’arte perduta
“Il popolo della città d i Bologna nei tempi addietro soleva essere occupato nelle manifatture di seta, di canapa e di lana, dalle quali tre arti grandissimo vantaggio ne risultava al pubblico, e privato bene, come è noto. I lavori di seta e delle canape sono tuttavia in qualche moto, perchè la quantità dell’una e dell’altra specie, che nasce nel territorio, non può [fare] a meno di non tener vive in qualche modo queste due arti. Quella della lana, che in altri tempi era maggiore dell’altre due, vivendo con essa 15 mila persone […], apparisce ora si può dir perduta. Massa dalla considerazione di un danno sì grande [Francesco Boschi] pensò di tentare, e far prova d’un qualche riparo allo svantaggio della patria, e prestar sollievo alla povertà, e perciò ha introdotto nella già Accademia del Porto Naviglio, a tal effetto comperata, la Fabrica o lanificio ad oggetto di provvedere di esso il nostro paese, e mandarne fuori. […] Ha messo in piedi una gran quantità di ordegni, ed instrumenti, occorrenti per tutte le manifatture, di pettinare, filare, tessere, ridurre a perfezione e perfino a tingere i lavori, di tal maniera che introdotta la lana in fabrica, fu atta ad esser tagliata in abiti. Ha condotto a grandi spese uomo di abilità per dirigere il tutto. […]. (Boschi, b. 520).
Chi scrive è Francesco Boschi, in una supplica del 1743 indirizzata al Pontefice per ottenere l’esenzione dei dazi delle lane per la sua Fabbrica de’ panni, lanificio fondato nel 1734 in Via del Porto a Bologna. Francesco era figlio di Paris Boschi, un ricco mercante di seta morto nel 1718.
Intorno al 1730, anno in cui fu fatto Marchese, fu promotore di due iniziative imprenditoriali nel settore tessile: per la canapa con la Fabbrica delle tele, nel 1733, insieme al Marchese Francesco Zambeccari, al conte Filippo Legnani Ferri e al mercante Francesco Scarani; per la lana con la fabbrica dei panni, nel 1733-34, insieme al marchese Paolo Magnani e a Filippo Legnani Ferri.
Due iniziative dalle caratteristiche diverse: la prima, la Fabbrica delle tele, ancora all’interno di un modello protoindustriale basato sul lavoro a domicilio, sia di città che di campagna, con uno stabiimento di modeste dimensioni, e ancora decisamente collegato alle corporazioni, nello specifico quella dei Tovagliari; la seconda, la Fabbrica dei panni, puntando sulla concentrazione della forza lavoro all’interno di uno stesso edificio, prefigurando un’organizzazione che sarebbe stata propria della Rivoluzione Industriale.
In entrambe le nuove imprese Boschi aveva tratto spunto da esperienze maturate fuori del territorio della Legazione. Così, per la Fabbrica delle tele, avendo osservato che per fare tele “all’uso di Germania è necessario un edificio a similitudine di una valchiera”, venne inviato il “bravo ingegnere” Rocco Mazza (successivamente direttore del lanificio) “nel sito a noi vicino dove si trova un simil edificio”, e cioè a Bolzano, “per osservare gli edifizi che colà si praticano per perfezionare le tele di qualcunque sorta”. Nonostante la “gente molto sospettosa”, il Mazza tornò in patria con preziose informazioni (Boschi, b. 520).
Per il lanificio, invece, si avvalse direttamente di un esperto tecnico veneziano, “uomo versato e pratico in tale professione”, Francesco Zabbeo, che rivestirà un importante ruolo nella prima fase della storia della Fabbrica dei panni. Del resto, nella Repubblica di Venezia si stavano sperimentando, nei decenni tra fine Seicento e inizio Settecento, nuovi modelli produttivi e di organizzazione del lavoro proprio in quel settore.
La scrittura privata del dicembre 1733 indicava le caratteristiche principali dell’accordo:
“Havendo gli Ill.mi sig.ri marchese senatore Paolo Magnani, conte Filippo Legnani Ferri e Francesco Boschi fissata l’idea di far risorgere in questa città le manifatture altre volte in essa praticate in genere di lana, hanno perciò pensato di prevalersi della persona ed arte del sig. Francesco Zabbeo veneziano, al quale hanno promesso di dare il comodo di poter dare prove di lui, somministrandole tutto il bisognevole d’arnesi, lane, contanti, che porterà la necessità di far vedere a suddetti Ill.mi signori ciò che possa fare in serviggio di questo paese, riservandosi però detti Ill.mi signori che non debba fabbricare quelle robbe che presentemente di fanno da questi fabbricatori dell’arte della lana, cioè perpignani, rasse, droghetti ordinari, frandine, fanelle, baiette, e panni ordinari frateschi, e viceversa si riserva il suddetto sig. Zabbeo che in tempo della di lui direzione non abbiasi da fare panni all’uso di quei di Padoa, e Venezia, né possa essere costretto da persona alcuna etiam d’autorità a fabbricarne, né mai ad insegnarne la maniera, essendo dote della di lui patria” (Boschi, b. 520).
Compito principale del direttore era dunque quello di sperimentare un prodotto nuovo, diverso da quelli allora sul mercato, ed al di fuori dei condizionamenti produttivi che l’Arte della lana avrebbe potuto esercitare.
Nel 1734 Zabbeo si mise all’opera nell’eificio di via del Porto: i presidenti dell’Accademia avevano “prestato a Francesco Boschi per qualche mese detto sito perché fosse ivi fatta qualche prova”, che evidentemente ebbe successo, e così nel 1735 Boschi, rimasto socio unico, prese ufficialmente in affitto una porzione del palazzo.
Zabbeo si mosse in più direzioni. Innanzitutto era necessario procurarsi la materia prima, la lana. Per fare ciò, in alcuni casi si recò di persona a Rovigo e in Polesine, nel ferrarese e a Venezia. Acquistò poi lana a Padova, a Roma e in Puglia, ma anche in Spagna e nel Levante, fatta arrivare al porto di Venezia.
Per il 1736 è documentata la partecipazione della Fabbrica dei panni all’importante fiera di Senigallia (Boschi, b. 525), dove Zabbeo comprava lana “lavata” dai mercanti, mentre le “lane succide, che si comprano dalli pastori”, provenivano soprattutto dal Polesine. Vendeva poi i panni a mercanti di Livorno, Venezia e Ancona. Spesso le operazioni di compravendita prevedevano il ricorso al baratto. Con l’utilizzo di vetturini, oppure per vie d’acqua, dal porto di Pontelagoscuro le merci acquistate, o scambiate, giungevano a destinazione a Bologna.
In quei primi anni acquistò le attrezzature necessarie alla fabbrica, come per esempio una “soppressa” (strumento in legno composto da due assi, per comprimere i panni) e una “chiodaria” (stenditoio in legno per l’asciugatura).
Furono anche assunti diversi lavoratori, alcuni dei quali veneti, esperti delle varie fasi della lavorazione della lana, affinché insegnassero il mestiere alla manodopera generica. All’inizio degli anni Quaranta gli addetti oscillavano tra le 50 e le 60 unità. Una ventina di operai si occupavano delle varie fasi della lavorazione, 15 “a filare”, una decina erano tessitori, tutti con retribuzione settimanale; ad essi si dovevano poi aggiungere una dozzina di “giornalieri”, assunti a seconda delle necessità di produzione. In particolare, “nelle prime operazioni, come di nettare, verghizzare, conciare, pettinare, e filare la lana, s’impiega un numero grande di persone, per la maggior parte donne vecchie e piccoli ragazzi, incapaci di altri lavori. Molte altre se n’impiegano poi ne’ lavori di maggior impegno, cioè nell’ordire, tessere, valcare, cimare, garzare, tingere, stirare, recimare, suppressare” (Boschi, b. 520).
Naturalmente il tradizionale ruolo del lavoro a domicilio, esercitato per secoli nel settore tessile, almeno inizialmente non rimase del tutto estraneo a questa esperienza. Nel 1735 “stame soprafino [viene] purgato consegnato in più volte a Matteo Gamberini, tessitore”; inoltre, uno dei telai utilizzati per la tessitura era stato affidato a una tessitrice esterna (Boschi, b. 520). Ma fu un impiego marginale. Alcune fasi del processo produttivo rimasero, per i primi anni, esterne all’opificio. La valchiera (operazione e relativo strumento per feltrare e rinforzare i panni) non era ancora presente nell’edificio, “e quando vi era bisogno di valchierare li panni, li portavano a delle altre valchiere lì in quelle vicinanze” (Boschi, b. 523).
Ma quello che è importante sottolineare è il distacco di questa esperienza dal modello protoindustriale, caratterizzato dall’ampio ricorso al lavoro a domicilio, tipico sia del settore della seta (che impegnava manodopera a domicilio della sola città) che di quello della canapa, che si stava riorganizzando, sempre su impulso di Francesco Boschi, nella neonata Fabbrica delle tele, impiegando lavoro domestico sia della città che del contado.
Le principali caratteristiche della nuova iniziativa imprenditoriale erano chiare: ricorso a un know-how esterno e prestigioso per il rilancio del settore, concentrazione delle attività produttive in un unico ampio opificio, ruolo marginale del lavoro a domicilio, autonomia rispetto ala corporazione, l’Arte della lana, e alle sue regole ferree.
Come già ricordato, nel 1737 l’Accademia cercò di vendere l’edificio di Via del Porto al Senato bolognese, che aveva intenzione di farne un granaio pubblico. Nella sua perizia l’architetto Carlo Francesco Dotti descrive “il teatro e i suoi annessi col refettorio, capellina e stanza contigua situati lateralmente a detto teatro, e di più altra fabrica in seguito a detto teatro verso il porto suddetto, qual fabrica resta più bassa di detto teatro […], che di presente serve per la fabrica de panni e tentorie”; più oltre si trova la cavallerizza, fabbricato successivamente trasformato nella nuova tintoria.
Il teatro gli appare imponente: dopo averne preso le misure, riferisce “di potere in detta altezza far quattro piani compreso il piano terreno” (Confini, vol. 1).
Questa perizia è di particolare interesse perché descrive l’edificio, pur sommariamente, in una fase intermedia: non più sede del Collegio, ma non ancora, del tutto, sede della Fabbrica per panni.
Quello che più importava a Boschi era la volontà dell’Accademia di vendere l’intero edificio, al quale, naturalmente, era interessato, e si attivò subito. Come gli suggerì Zabbeo, il primo problema riguardava l’approvvigionamento dell’energia idraulica, necessaria per muovere le ruote della valchiera, che si progettava di costruire. L’edificio sorgeva nei pressi del Canale Cavaticcio: non che l’acqua non ci fosse – racconta un operaio della fabbrica nel 1745 – ma “solo poca, proveniente da un chiavichino, per uso dell’orto” (Boschi, b. 523).
Così, il 25 febbraio 1739 fu ottenuta la licenza dall’Assunteria d’Ornato per costruire un condotto “sotto la strada detta de Morelli che va al Porto Navilio, quale condotto mediante, si conducano le acque derivate per un buco di oncie 6 della chiavica, detta la chiavica grossa della Via Nuova, all’altra chiavica grossa, denominata la chiavica grossa delle Puliole, per inacquare non solo l’orto di ragione del detto sig. Boschi, detto l’orto dell’Accademia, ma anche per servizio della valchiera per l’arte di pannina” (Boschi, b. 523).
Visti i buoni risultati ottenuti, e la possibilità di avvalersi dell’energia idraulica, nel 1740 Francesco Boschi affittò l’intero edificio e due anni dopo lo acquistò.
Il 4 settembre 1742 i presidenti dell’Accademia del Porto vendettero a Francesco Boschi “lo stabile qui sotto da descriversi, il quale formava già l’abitazione e commodo de’ sig.ri convittori della così detta Accademia del Porto, da alquanti anni in qua chiusa per mancanza di convittori; avendo considerato, anzi per prudenti ed economici motivi risoluto di non volersi più valere di detto stabile a tale uso, ed inoltre, che per la situazione fuori di mano, e lontano dall’abitato sarà malagevole l’affittarlo a qualche persona benestante […], ed avendo per l’altra parte i sig. Francesco Boschi in detto stabile a lui da sette anni in qua affittato da detti presidenti, intrapresa ed introdotta, mediante persona perita, con spesa considerabilissima la Fabbrica di panni, e di altre robbe di lana, a fine massime di bene pubblico, e a vantaggio del paese e della povertà, e perciò per lo stabilimento, e sicurezza di tale fabbrica in detto sito a tante sue spese già introdottavi, avendo creduto espediente di accudire alla compra di detto stabile […]” Boschi (b. 520).
Organizzazione della fabbrica
Nel febbraio 1743, quando Francesco Boschi aveva già acquistato l’intera proprietà dell’edificio e si apprestava a effettuare importanti investimenti, venne rinnovato il contratto con Zabbeo, il direttore della fabbrica. Ma a sorpresa, appena due mesi dopo, Zabbeo si dimise, annunciando di volere “portarsi alla propria patria, sì per accudire al ristabilimento dei salute della sua consorte cui asserisce essere nociva quest’aria, come ancora per accudire ad altri suoi vantaggiosi interessi” (Boschi, b. 520).
La fabbrica, che stava vivendo un momento delicato, con un importante processo di ampliamento e riorganizzazione in corso, rimase senza direttore. Il figlio di un collaboratore di Boschi, Antonio Bianconi, pur avendo svolto un periodo di apprendistato sotto la guida dello stesso Zabbeo, non era ancora pronto per assumere il comando delle operazioni. Su proposta di Bianconi padre, di lì a poco nel ruolo di direttore della fabbrica fu assunto il bolognese Claudio Menghelli (nel 1752 poi sostituito da Rocco Mazza), “il quale ha piena cognizione di tutto ciò che è relativo a fabbriche d’ogni sorta e qualità di panni” (Boschi, b. 520).
La crisi sembrò essere superata, e si poté procedere all’ampliamento dell’edificio, per concentrarvi l’intero ciclo produttivo, dal trattamento della materia prima, la lana grezza, alla vendita finale dei panni.
Mastro Giuseppe Fontana, su ordine di Zabbeo, costruì dunque la chiavica sotterranea “per la quale vi venissero delle acque a sufficienza per fare andare le pille esistenti nella medesima valchiera”. Un pezzo poi della chiavica della misura di una pertica (3,8 metri) era scoperta, per permettere il lavaggio dei panni (Boschi, b. 523).
L’energia idraulica era assicurata, ora si potevano costruire la valchiera (o meglio: un edificio con 3 valche) e ricostruire la tintoria, ingrandendola, in modo da assicurare il controllo e la completa centralizzazione dell’intero processo produttivo.
Osservando la mappa del 1781 si possono notare le nuova costruzioni: dietro al corpo principale della fabbrica la tintoria, e in basso, verso il Canale Cavaticcio, la valchiera che, dopo avere ricevuto le acque del condotto le scaricava nel sottostante canale.
La costruzione della valchiera, che Zabbeo aveva suggerito caldamente a Boschi, aveva comportato un importante investimento. Serviva per la “follatura”, una delle operazioni finali, per infeltrire i panni e rendere il tessuto più resistente e impermeabile. Per battere i panni veniva utilizzata una mazza grande di ferro (maglio), azionato dall’energia idraulica.
La tintoria (“tintoreria” nei documenti), un ampio ambiente lungo 70 piedi, largo 33 e alto 29, fu costruita separatamente, ma comunicante, rispetto alla fabbrica, dalla parte del Cavaticcio. Gli elementi in muratura erano tre vasche, i “battocchi”, e nove “fornaselle”, sette grandi e due piccole, che servivano per portare ad ebollizione la miscela di colorante e acque, per agevolare il fissaggio del colore.
Utilizzando un inventario del 1754 (Boschi, b.523) possiamo ricostruire l’intero processo di lavorazione della lana per la produzione sia di panni “alti”, di qualità, che “bassi”, più a buon mercato, così come avveniva all’interno della fabbrica di Via del Porto, dove era anche presente un magazzino per la vendita, garantita anche da una bottega esterna, il “negozio Taruffi”.
Processo di lavorazione
Le fasi principali erano quattro: preparazione, filatura, tessitura, “apparecchio”.
– Preparazione della lana
Le lane “succide”, cioè la materia prima grezza, le lane appena tosate, e non ancora lavate, venivano raccolte in “sacchi e sacchine”, pesate e successivamente lavate.
Venivano poi “verghizzate”, cioè battute. Per fare ciò le lane venivano sistemate sopra 3 grate di corda o vimini e poi pulite, quindi si poteva iniziare a separare le fibre. Gli addetti a tale operazione, che veniva eseguita in un’apposita stanza, prendevano il nome di “verghizzini”.
L’operazione successiva era la “cimolatura”, cioè la depurazione della lana: per fare ciò venivano utilizzate “due ramate di filo ferro, con cassa”.
Le “robbe in uso per rompere lana”, e pettinarla, consistevano in 6 cavalletti, alcuni “pettini grandi da stuffa”, cioè riscadati (la lana da pettinare era preventivamente unta d’olio), e vari attrezzi: spedetti di ferro da far “manelle”, cioè matasse, cagne, casse, corsetti, martellini. Il prodotto della pettinatura veniva chiamato “stame”.
Si procedeva poi alla “cardatura”, con le “robbe in uso da scartazzar lane”, attrezzi forniti di dentatura, le “pamole”, per eliminare le impurità e permettere di procedere alla filatura.
– Filatura
Operazione per ottenere un filo continuo, creando poi la matassa, Per tendere e contorcere le fibre venivano usati 40 mulinelli grandi, 3 naspi e 3 scagnoli per “inaspare”. Al termine, con l’aiuto di 2 “bilanze”, la lana filata veniva pesata.
Per “inacannare” e “ordire” venivano utilizzati 7 mulinelli, 200 rocchetti e 1 naspa. A quel punto i fili (ordito e trama) venivano disposti sul telaio.
– Tessitura
Entra in campo il telaio, “elemento chiave dell’industria tessile, all’epoca macchina semplicissima il cui aspetto e funzionamento sarebbe rimasto praticamente immutato dal Medioevo fino all’introduzione della navetta volante di John Kay brevettata nel 1733” (Panciera, 1985).
Nel camerone della Fabbrica del Porto, un tempo teatro, si trovavano 9 telai grandi e 6 piccoli, 22 pettini grandi e 21 piccoli, 25 “lizzi”, o licci, con i suoi “lizzaroli”, 11 spole grandi e 16 piccole, 1 rastello grande “per caricar lavori”, 15 “lizzi” doppi, 3 “lizzature nuove”.
Il tessuto era fatto, mancava un’ultima fase.
– “Apparecchio”
Dopo la tessitura iniziava una serie di operazioni finali del ciclo di lavorazione della lana, denominata “apparecchio”, che comprendeva varie fasi.
Innanzitutto la “purgatura”, per sgrassare e lavare i panni. Veniva utilizzato 1 “tinazzo per far lesciva” e 2 fittoni per strizzarli. Poi la “curatura” per sbiancare ed ammorbidire i tessuti, per la quale si usavane 3 tavole e 2 “curette”. Si passava poi alla “follatura” nella valchiera.
Successiva operazione era la “garzatura”: per ottenere una maggiore morbidezza, il pelo del panno veniva alzato grazie all’utilizzo di tavolette chiodate, i “garzi”. Nell’opificio si trovavano alcune scalette con crocette con garzi, 100 crocette senza sgarzi e 2 “stuore” con cerchi, “che formavano palle per tenervi i garzi sortiti”.
Passo successivo: il tessuto passava su di uno stenditoio, la “chiodera”, per asciugarsi. Nel prato dietro la fabbrica se ne contavano 3, e 2 nel granaio.
La “cimatura” consisteva poi nel rasare i panni con apposite forbici pesanti, 15 grandi e 3 piccole. Era presente inoltre una ruota per arrotolarle.
Anche se la “tentura” dei panni poteva essere fatta in momenti diversi del processo (talvolta anche prima della filatura: “tintura in fiocco”), a seconda del tipo di tessuto e delle diverse lavorazioni, secondo i documenti consultati, avveniva solitamente dopo la “cimatura”. Ma sull'”arte di tinger panni” si dirà più oltre.
Successiva operazione era quella di “suppressar panni”, utilizzando 1 suppressa grande e 1 piccola.
Quasi tutte le operazioni descritte venivano svolte ognuna in un’apposita stanza, dotata di tutte le attrezzature necessarie, anche se solo con la ristrutturazione degli anni Ottanta il processo si concluse, per esempio separando il luogo della tessitura da quello della filatura, che fino a quel momento convivevano nello stesso camerone. I panni così ottenuti venivano raccolti nel “magazzeno fillati e delle vendite”, dove si trovavano armadi, scansie, tavoli e bilance.
Interessante osservare, a sottolineare il sistema di fabbricazione, che tra le “robbe diverse in vari usi di lavoro”, era presente “una campanella per dar segno dell’entrata e dell’uscita degl’operari”.
Richiede un discorso a parte la tintura, un’operazione importante, “la più delicata dell’intero processo ed è senz’altro quella maggiormente protetta dal segreto professionale” (Panciera, 1985), nella quale venivano impiegati 6 addetti, che avevano a disposizione diverse attrezzature e un gran numero di “droghe”.
Oltre a utilizzare batocchi e fornaselle in muratura, gli addetti si avvalevano di “un mortaro grande di macigno, con pistone, e ferramenti per pistar zafrone”, lo zafferano, oltre a vari tini e mastelli in legno, caldare, calcedri e mescoli in rame, mortai, macini di marmo per macinare colori. E inoltre di un “tesibio di rame e piombo, con canoni di piombo messi sottoterra, che conducono l’acqua alle caldare”. Si trattava di un’antica macchina, una pompa per il sollevamento dell’acqua, già descritta da Vitruvio.
Interessante l’elenco delle “droghe”, coloranti e fissanti, prevalentemente di origine vegetale: sandalo (colorante rossastro), verzino (colorante rosso facilmente solubile in acqua), guado (una delle sostanze più importanti, che permetteva molte gradazioni di azzurro, dalla pianta omonima coltivata anche nel bolognese), robbia (colorante rosso), zafrone (zafferano), oricella (di colore violetto carico degradabile a paonazzo se trattata con robbia), scotano (il colore giallo carico ottenuto su fibre tessili poteva fissare un bel verde se queste subivano un impiumo al guado e l’elevato tenore di tannino, trattato con sali di ferro, donava sfumature di grigi e neri), indaco (composto appartenente alla categoria dei “coloranti a tino”, ovvero sostanze normalmente insolubili che devono essere trasformate in forme solubili per permetterne un uso tintorio).
Altre erano di origine animale, come il lumaco (tonalità di blu ottenuto dalla bava di lumaca) e la cocciniglia (colorante rosso), o minerale (verderame, vetriolo, corniola, limatura d’ottone, ferro, stagno).
Tra le “robbe ad uso di tintoreria” figuravano olio, utilizzato come ammorbidente, e sapone; in un piccolo ambiente a parte veniva poi distillata l’acquaforte, vale a dire l’acido nitrico.
All’interno della tintoria, un posto importante era occupato dalla “mordenzatura”, il procedimento grazie al quale venivano fissati i pigmenti su fibre e stoffa, attraverso la bollitura in acqua nelle fornacelle, dei mordenti, che nel caso della fabbrica di Via del Porto erano esclusivamente potassici, cioè allume di rocca, allora diffusissimo, tartaro, ma anche cenere, un ingrediente indispensabile per la preparazione del bagno di colore, che rendeva stabili le tinte. Come fissante per i colori veniva utilizzata inoltre la gomma arabica ricavata dall’acacia. Il risultato dell’attività della tintoria era una gamma di colori non indifferente.
In quegli anni però, all’interno della fabbrica, o meglio, della tintoria, non era ancora stato del tutto risolto il problema del fissaggio dei colori sulle stoffe, per “ottenere la qualità delle tinte durevoli come quelle de’ panni forestieri”. Grazie all’interessamento dell’Assunteria delle Arti, fu dato incarico a Laura Bassi, nota scienziata e fisica sperimentale bolognese, di “fare varie esperienze ed esami, al fin di verificare la ragione del male, e ritrovarvi l’opportuno rimedio” (Arti, b. XXXVI). Ma non portò a termine le sue ricerche, essendo venuta a mancare.
Il lanificio Pasquini ed oltre
Nel 1756 morì il fondatore della fabbrica, Francesco Boschi, e si chiuse la prima fase della storia della Fabbrica del panni di Via del Porto.
L’edificio rimase di proprietà della famiglia Boschi fino al 1848: in quell’anno fu acquisito da un importante imprenditore bolognese, Luigi Pasquini, affittuario fin dal 1818. Era il titolare del lanificio Pasquini, che intorno alla metà dell’Ottocento impiegava oltre 200 operai e disponeva di 80 telai. Il successo della sua attività trovò riscontro nella partecipazione alle Esposizioni nazionali e internazionali dell’epoca, ricevendo premi per la qualità dei suoi prodotti.
Fino al 1878, quando la fabbrica venne chiusa e gli operai licenziati. Nel corso del Novecento l’edificio fu ancora adibito ad attività industriali, sempre nel campo tessile, con il marchio A.M.B.A.
I discendenti del Marchese Francesco Boschi, fondatore della Fabbrica dei panni, hanno voluto richiamare alla memoria, in una delle stanze del loro palazzo di Via Castiglione, oggi destinato ad accogliere eventi privati o aziendali, l’importanza che la lavorazione della lana ha avuto per la loro famiglia.
Riferimenti archivistici e bibliografici
Archivio di Stato di Bologna (A.S.Bo.):
– Archivio Famiglia Boschi, Fabbrica dei panni, bb.520, 527 [=Boschi]. Nella Serie sono presenti documenti sia della Fabbrica dei panni che della Fabbrica della tele.
– Assunteria d’Arti, Miscellanea delle Arti, bb. IV-LIX [=Arti].
– Assunteria Confini e Acque, Mappe, piante e disegni, vol.1 [=Confini].
Ferrari R., L’area di Porto Navile a Bologna dal secolo XVI al periodo post-unitario, in Città e proprietà immobiliare in Italia negli ultimi due secoli, a cura di C. Carozzi e L. Gambi, Milano, Franco Angeli, 1981, pp. 311-336.
Guenzi A., La “Fabbrica delle tele” fra città e campagna. Gruppi professionali e governo dell’economia a Bologna nel secolo XVIII, Ancona, il Lavoro Editoriale, 1987.
Guenzi A., Acqua e industria a Bologna in antico regime, Torino, Giappichelli, 1993.
Martina D., Nobiltà e manifattura: la famiglia Boschi, tesi di laurea, Università di Bologna, Facoltà di Economia e Commercio, Rel. Prof. F. Cazzola, a.a. 1993-1994.
Matteucci A.M., Carlo Francesco Dotti e l’architetture bolognese del Settecento, Bologna, Alfa, 1969.
Nannelli P., Il porto e la Salara, in www.centrofasoli.unibo.it.
Panciera W., Articolazione della produzione e livelli tecnologici delle manifatture laniere di Schio nella seconda metà del XVIII secolo, “Quaderni storici”, 59, 1985, pp. 403-426.
Pesci G. Ugolini C., Venturi G. (a cura di), Bologna d’acqua. L’energia idraulica nella storia della città, Bologna, Editrice Compositori, 1994.
Problemi d’acque a Bologna in età moderna, Bologna, Istituto per la Storia di Bologna, 1983.
Tomasina G.P., Educazione progressista al Collegio del Porto: somaschi e gesuiti in concorrenza a Bologna nel secolo XVIII, in “Il Carrobbio”, n.38, 2010, pp. 109-139.