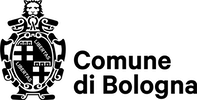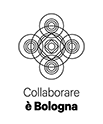Dai Cartigli del Comune di Bologna
Palazzo Comunale
E’ un aggregato di edifici di epoche diverse: nella facciata la parte sinistra, su archi, fu iniziata nel 1287, con statua della Madonna di Nicolò dell’Arca (1478); quella di destra si deve a Fioravante Fieravanti (1425). Il portale è di G. Alessi (1550-55), modificato da D. Tibaldi, con statua di papa Gregorio XIII, di A. Menganti (1576-80). Nell’interno si conservano affreschi di F. Francia, P. Fontana, G. Curti, A. M. Colonna, C. Cignani, G. A. Burrini, G. A. Caccioli, V. Martinelli e statua d’Ercole modellata da A. Lombardi.
Indirizzo:
Piazza Maggiore, 6
Palazzo Comunale
Il lato meridionale di questo vasto complesso di edifici conserva una notevole finestra in cotto quattrocentesca, di gusto lombardo. La torre d’angolo fu del tutto demolita durante un bombardamento nel corso dell’ultima guerra, e poi ricostruita. Di qui si ha accesso al grande cortile, ove avevano sede la guardia svizzera e gli addetti al palazzo. Al centro si trova una copia della cisterna progettata da Francesco Terribilia nel 1568, trasferita poi nel 1886 nel cortile della Pinacoteca Nazionale.
Indirizzo:
via IV novembre
Palazzo Comunale
Nella cortina muraria settentrionale del palazzo è inserita la bella fontana, eretta nel 1565 su progetto di Tommaso Laureti, con rilievi attribuibili allo scultore francese Jean Goujon. Questo angolo del palazzo ingloba i locali dell’antico carcere “del torrone” cosiddetto perchè inclusi in una torre. Dal portale si aveva accesso al “Giardino dei Semplici”, istituito nel 1568 come orto botanico secondo i consigli di Ulisse Aldrovandi. Sulla sua area sorse, nel 1886, su disegno di Filippo Buriani, la Sala della Borsa e la sede d’un ufficio postale.
Indirizzo:
via Ugo Bassi, 2
Dalle “Cose Notabili …” di Giuseppe Guidicini.
N.90. Pretende l’ Alidosi che questo edifizio siasi incominciato nel 1290, ed ampliato con compre fatte li 11 settembre 1293 d’ alcuni casamenti posti verso Porta Nuova appartenenti ai rettori delle chiese di Santa Tecla e di S. Silvestro, e cioè dal lato di sera. Aggiunge che nella fabbrica vi fu compresa una casa dei Lambertazzi pagata L. 300, della quale conservavasi a’ suoi giorni una scala di 40 gradini di gesso, che corrosi dall’uso e dal tempo furon rivoltati circa il 1611. Questa scala è la così detta degli Anziani, che trovasi a capo del loggiato subito a sinistra dell’ ingresso del pubblico palazzo. Dice finalmente che frate Pietro Nazzari, depositario del Comune, pagò nel 1294 L. 3000 ai soprastanti alla fabbrica di questo palazzo.
Si ha però notizia dal libro dei Memoriali che sul finire del 1244 si fecero alcune compre di terreno in questa situazione, le quali indicano il progetto di erigere qui un palazzo, per cui si crede cominciato nel 1245. Si ha notizia certa che nel palazzo nuovo vi siano compresi i seguenti stabili :
1° Presso la torre dell’ orologio, creduta comunemente dei Lambertazzi, ma senza fondamento, vi erano le case del famoso Glossatore Accursio, sulla morte del quale non son concordi gli storici, mentre qualcuno lo dice morto nel 1229, altri nel 1265 di anni 78, certuni nel 1267 d’ anni 75, e finalmente chi nel 1275 in età d’ anni 78.
Ebbe egli due figli, Francesco e Cursino, al primo toccarono per eredità paterna tre delle quattro parti di queste case, e al secondo l’altra quarta parte, che fu da lui venduta, o data in permuta a Martino del fu Bolognito Merolite.
Francesco d’ Accursio e Martino di Bolognito le vendettero li 14 febbraio 1287 a Cumino de Scardelli sindaco e procuratore delle genti e dell’università dei Geremei della città di Bologna, come da rogito di Iacobuccio dal Bagno, nel quale si dice che questa casa con torre è sopra la piazza del Comune di Bologna in cappella Santa Tecla. Confina a oriente colla piazza e colla pubblica via della Piazza Maggiore, ad aquilone colle case e colla torre dei figli del fu Nevo di Rainerio Guezi, a occidente, ossia di dietro, con i beni della chiesa di Santa Tecla, e a mezzodì colla via pubblica per la quale si va a Porta Nova. Nel contratto è detto espressamente esservi compresa la torre tanto interna che esterna. Il prezzo fu di L. 3700 di bolognini grossi, moneta bolognese. Rogito di Francesco d’ Ivano de’ Bentivogli notaro.
Dunque la torre in oggi dell’ orologio era quella di Accursio, e non dei Lambertazzi, quando però non si fosse continuato a dirla dei Lambertazzi anche dopo che colle case ad essa aderenti era stata venduta all’ Accursio.
2° Poco dopo la vendita di Francesco Accursio, fu comprata dalla parte Geremea la casa di Nevo di Riniero Guezi padre della moglie del predetto Accursio, per lire 2000, prezzo cospicuo a quei giorni, e che la qualifica per casa grande e per una delle primarie della città.
3° In seguito agli stabili predetti e dalla parte di settentrione vi era la via Cavalara, la quale si dirigeva da levane a occidente alle case dei Tebaldi. Questa nella direzione delle scale del Torrone era intersecata da altra strada, che si spiccava da Porta Nova, ossia da mezzogiorno, e terminava verso la chiesa di Sani’ Ippolito , poi detta Santa Barbara, a settentrione. Dove succedeva l’intersecazione di dette strade si diceva l’angolo delle quattro strade.
4° Dopo la via Cavalara eravi quel tratto di fabbrica con otto finestre ornate di cotto, che è la parte fabbricata al tempo di Taddeo Pepoli, come si vedrà in appresso. È probabile che qui fossero i terreni, che come si è detto superiormente vennero acquistati dal Comune nel 1244 secondo il libro dei Memoriali.
5° Continuando verso settentrione venivano le case di Guglielmo Panzoni, detto da qualcuno Garzoni, qualificato da Oddofredo per legista singolare, che del 1248 copriva la carica di giudice e presidente all’esame dei notari, i cui quattro figli figurarono sul finire del XIII secolo. Abitavano i Panzoni in cappella di S. Bartolomeo di palazzo, e precisamente dove erano le così dette botteghe degli scaffieri. Queste loro case arrivavano fino all’ angolo della via delle Volte dei Pollaroli.
6° Nel fianco del palazzo che guarda settentrione, e che corrisponde alla predetta via delle Volte dei Pollaroli, vi erano i casamenti dei Tebaldi, chiesti dal Reggimento per ampliare il palazzo, ma rifiutati dai proprietari.
Li 3 maggio 1341 morì certa donna dei Tebaldi che li lasciò per legato al Comune, coll’ obbligo di distribuire ogni anno 440 corbe di frumento ridotte in farina ai poveri della città. Questo canone fu poi dal Reggimento addossato ai dazieri delle moline e dello sgarmigliato, colla dichiarazione che s’intendeva che ogni corba di farina pesasse libbre 160, perciò in totale libbre 70400, dalle quali detratte libbre 5632 per la macina e libbre 3160 per i poveri vergognosi, si distribuivano ai poveri della città metà a pasqua di risurrezione e metà a natale le residuali libbre 61608. Questa distribuzione si faceva mediante 1760 ferlini, o marche grandi e piccole, colle armi del Papa, mercè le quali, se la marca era delle grandi, riceveva il presentatore un quartirolo, o libbre 10, e se delle piccole un mezzo quartirolo, o libbre 5 di farina.
Li 15 marzo 1383 fu fatta la provvisione sull’elemosina della farina da distribuirsi dai magistrati due volte all’anno, e cioè di dare la farina per corbe 200 di grano a pasqua di risurrezione, ed altrettanta a natale ai poveri della città. Fu adottato il progetto con 273 voti favorevoli, uno contrario ed uno neutro. Rogito Matteo di Giacobino, alias Minotto Angelelli notaro dell’ ufficio delle Riformazioni.
Il primo aprile 1558 fu decretato che la distribuzione dei ferlini si facesse il mercoldì santo e la vigilia di S. Tommaso.
7° Sulla via della Piazzola del carbone corrisponde il lato occidentale del pubblico palazzo, sul quale si manca di notizie intorno ai possidenti che vendettero stabili e suolo in questa situazione.
8° Per il lato meridionale in via Porta Nova sappiamo che li 18 febbraio 1359 il Comune comprò la torre e la casa dei Lapi in contrada Porta Nova rincontro la via degli Agresti, per L. 400.
9° Al di là, andando verso piazza, vi era una casa con botteghe in cappella di S. Martino dei Caccianemici, di proprietà di Giovanni e di Guidocherio Cavalieri Galluzzo e di Francesco e Nicolò loro figli, i quali la vendettero a Bartolomeo Conforti, e questi li 26 gennaio 1337 la cedette a frate Guglielmo del fu Giacomo, del terz’ordine degli Umiliati, depositario della Gabella, che l’ acquistò a nome del Comune, la qual casa fu fatta demolire nel novembre del 1336 per ordine degli Anziani onde fortificare il palazzo del Comune, dove allora dimoravano. Il Conforti aveva già ricevute L. 599, e li 26 gennaio suddetto fu ordinato il pagamento di altre L. 260, 10, 3, come si rileva dal registro nuovo.
10° Si è detto che dietro le case di Accursio vi erano stabili della chiesa di Santa Tecla, i quali necessariamente saranno stati acquistati e compresi nel palazzo, ma gli è pur certo che in questi contorni vi era una chiesa dedicata a Santa Tecla, che dicesi edificata nel 1222, alla quale fu unita nel 1293 quella di S. Silvestro, atterrata in occasione dell’ ampliazione fatta al palazzo della Biava. E qui cade in acconcio l’avvertire come nelle vicinanze della piazza vi fossero due chiese dedicate a Santa Tecla. L’una detta Santa Tecla dei Lambertazzi, che fu atterrata per la fabbrica della chiesa di S. Petronio; l’ altra di Porta Nova, o dei Guezi, non dei Lambertazzi, come da tanti si è erroneamente ripetuto, ed è quella a cui fu unita l’ altra di S. Silvestro che nel 1390 fu distrutta dalle fiamme e non più rifatta, ed il suo suolo servì ad ampliare il pubblico palazzo.
Qualche autore ha ricordato una chiesa di S. Bartolomeo dei Lambertazzi con cura d’ anime nel 1290, compresa nel recinto del palazzo del Legato, per cui tal chiesa prese il nome di S. Bartolomeo di Palazzo, e che conservata nei successivi ingrandimenti del palazzo fu accresciuta di giurisdizione col circondario della parrocchia di S. Giusta soppressa nel 1501. Questa chiesa di S. Bartolomeo non ha mai avuto il nome dei Lambertazzi, nè mai è stata compresa nell’ sola del palazzo. (Vedi via delle Volte dei Pollaroli).
Li 4 ottobre 1429 Nicolò di Pietro Fava comprò dalla compagnia dei biselieri e panni di lino una casa sotto S. Martino dei Caccianemici piccoli, posta in Porta Nova, che di dietro confinava col palazzo del Legato, e dalle altre parti colla bottega di Petronio Speziale e con beni dell’ ospedale della morte, pagata L. 200. Rogito Giacomo Terzi. Questa casa fu poi atterrata, e pare circa il 1436 in occasione dell’ ampliazione del palazzo nuovo dalla parte di Porta Nova.
Gli stabili di Accursio e del Guezi uniti assieme formarono il così detto palazzo della Biava. Si sa che i primi nel 1289 servivano a granaio pubblico, e i secondi agli ufficiali destinati a ricevere le denunzie dei cereali.
Nel 1293 essendo uffiziali della biada Visconte Visconti, Orio Bianchetti e Iacopo Pavanesi fu cominciata una fabbrica nelle case della biava, dopo di che si trova che il mercato delle granaglie, che già fino dal 1222 si teneva nel Mercato di Mezzo presso il trivio di Porta Ravegnana, si cominciò a tenere nel palazzo dove si denunciavano le biade.
Nel 1297 gli uffìziali suddetti, già rivestiti di molta autorità, furono ancora incombenzati di pagare i dottori e i soldati.
Correndo l’ anno 1301 vollero i bolognesi testimoniare a Papa Bonifazio VIII la loro riconoscenza e gratitudine, e per questo ordinarono a Manno, orefice bolognese, la statua di quel pontefice di rame dorato, che fu posta sotto un baldacchino nella facciata del palazzo della biada. Spese il Comune, tutto compreso, la somma di. L. 420. Nel 1378 fu poi rimossa e collocata sopra la ringhiera degli Anziani.
La camera degli Atti, ossia l’archivio, stabilito prima del 1255, si riconobbe con tenere molti libri vecchi ed inutili, perciò li 11 febbraio 1303 fu ordinato di separarli, e di depositarli in Domo Pratus, sive in una ex cameris palatij Bladij. Questo parziale deposito di atti fu in gran parte distrutto dall” incendio seguito nel 1313, ma fu risparmiato da quello che ebbe luogo li 17 maggio 1334, quantunque distruggesse gran parte di questo locale.
Si trova che nel 1324 fu gettata in S. Procolo una campana di libbre 11666 detta dell’ Arrengo, che fu poi posta nella torre, del Comune.
Nel 1356 fu levata la campana grossa, detta dell’ Arrengo, dal palazzo della biava dove abitava l’ Oleggio, e li 19 marzo fu posta sulla torre del capitano, dove per ordine del detto Oleggio fu messo un orologio.
Si trova pure che del 1327 nel palazzo della biava vi erano stabilite delle carceri.
Li 2 ottobre 1336 fu decretata l’ unione al palazzo del Podestà delle case dei Lambertini, nelle quali risiedevano gli Anziani, e si ordinò che questi passassero al palazzo della biava, facendo sloggiare da esso i dazieri del vino dietro un’ indennità per le spese occorrenti al traslocamento dei loro uffici.
Li 4 ottobre dell’ anno medesimo gli Anziani, consoli e il Gonfaloniere di giusti zia presero posto nella nuova residenza assegnatagli.
Nel susseguente novembre fecero atterrare le volte, o loggie (portici), addossate a questo palazzo sulla via di Porta Nova.
Li 5 febbraio 1337 gli Anziani e Consoli elessero Gera di Romeo Pepoli a sopraintendente ai lavori da farsi nel palazzo nuovo del Comune. Rogito Guido di Guido Speziale.
In quest’ anno l’ uffizio, il mercato delle biave e i granari pubblici furono stabiliti nel Mercato, ove adattarono a tal uopo Io stabile N. 2022 e 2021 nella via Imperiale, ove li 9 novembre 1337 fu tenuta la prima fiera del grano.
Li 6 luglio 1337 per ordine degli Anziani furon fatte demolire le beccarie che erano aderenti alla loro nuova residenza.
Li 25 giugno 1338 fu finito di fabbricare quella parte di palazzo dei Signori posta sul canto delle quattro strade verso S. Pietro e rimpetto alla via Cavallara che andava alla casa dei Tebaldi.
Taddeo di Romeo Pepoli fu eletto conservatore e governatore perpetuo del comune, popolo, città e contado di Bologna li 30 agosto 1337. Rogito Cristoforo di Filippo di Giovanni da S. Miniato.
Nel 1338 proseguendo i magistrati la fabbrica del palazzo pubblico, e volendola accrescere in quella parte che comprende lo spazio dalla porta attuale del detto palazzo a tutto l’angolo rimpetto alla fontana del Nettuno, fu posta da Taddeo la prima pietra fondamentale li 25 giugno 1338 nel suindicato angolo dove aveva principio la via delle Scudelle.
Dopo la morte di Taddeo Pepoli, seguita alle ore 2 1/2 della notte delli 29 settembre 1347, essendosi li 16 ottobre 1350 venduta Bologna da Giacomo e Giovanni del fu Taddeo Pepoli all’arcivescovo di Milano, come da rogito di Ippolito di Lanfranco e di Giorgio de’ Bolani, notari milanesi, mandò il Visconti al governo di questa provincia Gio. Visconti da Oleggio, che alloggiò nel palazzo della Biava. L’ Alidosi dice che il Consiglio, trovando angusto il sito dove si depositavano gli atti nel predetto palazzo, e di più soggetto agli incendi, come superiormente si è veduto, determinò nel 1357 che i rogiti dei notari fossero collocati nel salone sotto quello detto del Re Enzo nel palazzo del podestà.
Dicesi dagli storici che nel 1352 fu fabbricata la torre delle prigioni, la quale nel 1403 si disse torre dell’orto del palazzo, e serviva di carcere ai grandi, e che fu poi alzata come si vede al presente sotto la Legazione del cardinal Montalto.
Nel pontificato di Pio VIII e sotto la legazione del cardinal Bernetti furon levate le carceri dal detto torrazzo nel 1830, e trasferite in S. Gio. in Monte.
La porta annessa si vide compita ed aperta li 12 ottobre del predetto anno.
Nel 1365 il Cardinale Androino circondò di mura e di torri tutta quella parte del palazzo che comincia dall’angolo rimpetto alla fonte del Nettuno fino a quello della via della Volta dei Pollaroli, continuandole per ambedue i lati che guardano settentrione e ponente, e proseguendole dalla parte di mezzodì fino ad incontrare il risalto di fabbrica del palazzo in via Porta Nova rimpetto alla via dei Fusari, alias della Baroncella. Una delle predette torri fu costrutta nell’angolo delle Volte dei Pollaroli, alla quale si comunicava dal palazzo mediante un corridoio di legno che bruciò il 15 settembre 1425 e che fu rifatto di pietra. Addossato al muro di ponente si costrussero le abitazioni per i soldati, e si formò il vasto giardino che coincide dove furono le case dei Pulzoni e dei Tebaldi. Racconta uno storico che vedendo il popolo erigere questo muro fortificato da torrioni credette che si fabbricasse una fortezza, quando non fu che il circondario di un orto. La spesa ammontò a L. 9170.
Nel 1425 arse buona parte del palazzo e le stalle. Si diede mano alle riparazioni e si fabbricarono le due prime loggie del cortile, e cioè quella dalla parte della porta del palazzo dove erano scale di legno che ascendevano a tutti i piani, e l’altra che termina al loggiato degli scaloni principali del medesimo.
In quest’ anno la merlatura del palazzo che cominciava dall’ angolo del registro, ossia da Porta Nova, fino alla porta, fu continuata fino all’ angolo rimpetto alla fontana del Nettuno.
Nel 1436 si aggiunse di fabbriche l’interno del palazzo del Comune dalla parte di Porta Nova, al qual lavoro presiedette Paolo abbate di S. Gaudenzio.
Nel 1437 fu alzato, merlato e finito il muro grosso del palazzo dei Signori verso Porta Nova a cominciare dal cantone della banca dei soldati (rimp etto alla via dei Fusari) sino alle beccarie di Porta Nova al torrione vecchio, cioè alla piazzola del Carbone, poi voltando verso Fieno e Paglia (via della piazzola del Carbone) sino alla torre dell’orto del palazzo, oggi detta torre delle carceri.
Orazio pittore nel 1440 prese in affitto per annue L. 8 di picchioni la torre dei Cherubini, o del Cherubino, e cioè quella già dei Lapi in faccia alla via dei Gargiolari, la qual torre era stata assegnata ai domenicani in compenso di botteghe di loro ragione atterrate dal popolo sulla piazza prima del 1428. Rogito Panzacchia. I Padri domenicani la vendettero li 26 aprile 1473 a Giacomo detto Betto, o Bello, beccaro. e a Benvenuto suo figlio, per L. 160 di bolognini d’argento equivalenti a L. 173, 6, 8 correnti. Rogito Matteo Tossignani.
Il Comune ricuperò la torre, e servì per molti anni a deposito di polveri. Circa il 1800 essendo prefetto del Reno Somenzari fu ribassata al punto nel quale oggi la vediamo.
Li 17 dicembre 1444 gli Anziani, Consoli e Gonfaloniere di Giustizia concessero a Giovanni del fu Evangelista da Piacenza, e a Bartolomeo di Gandolo del fu Rustigano Pariani oreflce, d’ innalzare e fabbricare una nuova torre per l’ orologio nell’angolo del palazzo rincontro la piazza verso l’uffizio delle bollette, da compirsi in nove mesi, colla mercede di L. 1800 per le spese, e di L. 5 al mese a ciascuno di essi per anni 30 in ricompensa della loro fatica. Rogito Antonio da Manzolino, Giovanni Tura e Filippo Formaglini.
Non si intenda però per nuova torre se non che la parte di fabbrica che sopravvanza il quadrato della torre così detta dei Lambertazzi. L’ orologio che era sulla torre del capitano nel palazzo del Podestà fu trasportato in questa, e cominciò a batter le ore senza mostra li 2 agosto 1451. La mostra fu finita li 22 dicembre susseguente. La campana suonava tante volte quant’erano le ore dall’ una alle ventiquattro, poi si passò all’ altro estremo di farla battere dall’una alle sei, e ripeterle in questa quantità quattro volte per giorno.
Nell’ ottobre del 1447 il Legato fece aprire una porta secondaria e privata sotto la ringhiera degli Anziani e in faccia alla scala creduta dall’Alidosio per quella delle case dei Lambertazzi. Informato il Papa di questa innovazione ordinò che fosse subito murata, siccome seguì dopo essere rimasta aperta quindici giorni.
Nel 1455 si spesero L. 10910 per fare gli alloggiamenti al Legato cardinal Bissarione, e nel 1460 furon fatte in volto la sala poi detta d’ Ercole e le due salette annesse al quartiere degli Anziani, nella prima delle quali fu fatta la cappella per il detto magistrato.
Li 21 dicembre 1465 il Reggimento deputò mastro Masaccio pittore a far egli solo quei lavori della sua arte che potevano occorrere alla Camera di Bologna, da pagarsi per il prezzo consueto.
Li 28 ottobre 1409 fu approvata l’erezione di una cappellata degli Anziani, e fu nominato cappellano il Padre Giacomo de’ Palmeria dell’ ordine eremitano.
Li 30 dicembre 1471 fu eletto a siniscalco degli Anziani Bartolomeo Paganelli.
Li 28 maggio 1490 fu ordinato di spendere fino a 100 ducati d’ oro per riparare la torre dell’ orologio e della cancelleria in essa compresa.
Li 13 agosto 1492 in occasione dei fuochi di gioia per l’erezione al pontificato di Alessandro VI, s’ incendiò e fu distrutto il cupolino della campana. Li 29 susseguente si ordinò di rifarlo e coprirlo di piombo.
Li 24 settembre 1493 suonò per la prima volta la campana che si vide ricoperta del nuovo cupolino sostenuto da otto colonne di macigno.
Nel 1498 fu fatto il trabadello sopra la mostra dell’ orologio, per il quale, al battere di ciascun ora passavano le statue di un trombetta, dei tre Re Magi e della B. Vergine col bambino a cavallo di un somarello. Guastatosi il meccanismo nel 1796 non è più stato riattivato.
Li 16 agosto dell’ anno predetto fu decretato che i pubblici orologi si regolassero e suonassero alla francese, lo che fu messo ad esecuzione li 25 del susseguente settembre.
Il primo dicembre 1505 si ordinò la demolizione degli edifizi appoggiati esternamente al pubblico palazzo comprese le banche dei macellari, che erano in Porta Nova alla torre del Cherubino, sul conto delle quali si danno le notizie seguenti:
Li 20 dicembre 1440 fu data in enfiteusi perpetua in Bologna la torre del Cherubino presso il muro del pubblico palazzo, posta in cappella Santa Tecla, a Casotto del fu Guglielmo Caccianemici della cappella di S. Tommaso del Mercato, e a Giacomo di Pellegrino Ingrati della cappella di Santa Maria del Torrilione, per annue L. 10, colla facoltà di porvi banche da vender carne.
Questo terreno si estendeva dalla via pubblica (Porta Nova) verso quella di Fieno e Paglia (via della Piazza del Carbone) in larghezza di piedi 2 dal muro del palazzo fino alla via pubblica, di modo che la larghezza della via di Porta Nova rimaneva di piedi 15. La lunghezza poi a partirsi dalla torre del Cherubino andando verso Fieno e Paglia era di pertiche 1 e piedi 3.
La larghezza dal cantone del palazzo fino alla via pubblica di Fieno e Paglia era di piedi 5 e oncie 6, e la lunghezza dal detto cantone, in direzione di settentrione, fino in faccia alla casa del Battagliuzzo era di due pertiche.
La larghezza nel mezzo fra il cantone del palazzo e la torre del pellatoio (torre aderente al palazzo rimpetto al borgo delle Banzole) era di pertiche 2 e piedi 3, e la larghezza dal muro del palazzo alla via pubblica presso la torre del pellatoio era di piedi 8, restando la via Fieno e Paglia, dov’ era la detta torre del pellatoio, piedi 11, e in seguito piedi 13.
Li 5 maggio 1441 fu assegnato questo terreno dalla Camera al massaro e alla compagnia dei beccari in cambio di altro terreno ricevuto in Bologna da detta Camera presso le carceri vecchie del Comune, come da rogito di ser Filippo Manzolino.
Li 23 maggio susseguente il Caccianemici e il Grati vendettero i miglioramenti che trovavansi sul terreno in discorso al detto massaro e compagnia per L. 500 di picchioni. Rogito del suddetto Manzolino.
Il decreto della demolizione aggiunge :
“Considerando che dette banche ed ediflzi deformano il palazzo, si ordina l’ atterramento delle une e degli altri, dando commissione al magnifico Giovanni Bentivogli e al cav. Giovanni Marsili di eseguire il decreto e di dare i dovuti compensi ai macellari”.
Nel febbraio del 1508 furono atterrate 33 botteghe appoggiate al muro del pa lazzo, cioè 16 nella via delle Scudelle e 17 in Porta Nova, risparmiando da questa parte l’ oratorio fatto di recente e dedicato alla B. Vergine delle Asse.
Reso perfettamente isolato il palazzo, furono, li 20 aprile 1508. aperte 24 bombardiere nel suo circondario, e messa una saracinesca di legno coperta di ferro alla porta del palazzo, davanti la quale, per ordine del Papa, furono apposti due grossi fittoni con forte catena li 18 ottobre 1510 per barricarla all’occorrenza.
Il Papa nominava un capitano della porta del palazzo, che godeva di L. 600 di annui appuntamenti pagati dalla Camera di Bologna. Fu guardata da un corpo di tedeschi, poi svizzeri fino al 20 giugno 1796. In tempo di sede vacante i svizzeri erano armati di moschetto in luogo d’ alabarda, e la porta era contornata da una barriera di cancelli di legno, e difesa da due pezzi d’ artiglieria.
La loggia terza del cortile di palazzo, e cioè quella attaccata allo scalone, cominciata nel 1507, si vide terminata li 13 luglio 1509 assieme alle due scale a cordonata che ascendono prima alla sala d’ Ercole, poi a quella detta la Farnese, sotto la sorveglianza del senator Gio. Francesco Aldrovandi e la direzione dell’ architetto Bramante di Castel Durante mentre era tesoriere Virgilio Ghisilieri.
Ritornato da Milano il cardinal Legato Alidosio fu il primo a montar la scala a cavallo fino alla sala d’ Ercole.
Alla fine di agosto dello stesso anno 1509 furon terminate le stalle del Legato corrispondenti al giardino.
Li 10 dicembre 1509 il Legato Francesco Alidosio accordò L. 8000 a due muratori per fare le loggie di sopra, le camere degli Anziani, le stanze del Gonfaloniere, del Legato, delle loro famiglie, e diverse scale di comunicazione pei detti quartieri, lavoro portato al suo termine nel 1510.
Essendosi posta la statua di Giulio II sopra la ringhiera degli Anziani nel 1506. In questa devastata e bruciata li 5 giugno, o 23 maggio 1511, da Sante Sighicello e da Pietro Zuta in tempo del tumulto seguito per il ritorno in Bologna di Annibale Bentivogli, i quali furon messi al bando capitale.
Li 10 febbraio 1520 Leone X confermò Vincenzo Borgognini della parrocchia di Sant’ Antonino di Porta Nuova nell’ ufficio di tener coperti i palazzi del Legato, degli Anziani e del Podestà.
Le stanze dette le Morone verso il giardino sono opere fatte nel 1547 e 1548. a questa fu poi aggiunta la galleria che faceva parte del quartiere del Legato.
Nel 1561 furon costrutte le Bandine coll’ impiego della condanna di scudi 10000 inflitta al senator Ercole di Giovanni Bandini, le quali ultimamente componevano l’appartamento che era occupato dal senatore di Bologna.
Nell’ anno stesso il cardinal Carlo Borromeo fece la parte interna del braccio che dall’ angolo della facciata contro la fontana del Nettuno termina nella via del Volto dei Pollaroli.
L’ esterno fu fatto ornare nel 1565 dal Legato Donato Cesi.
Nel 1565 dalla parte della via detta Volte dei Pollaroli fu fatta, con disegno di Tommaso Lauretti, la fontana larga .piedi 20, che riceve acqua dalla fontana del Nettuno, e che prese il nome di fontana vecchia. Qui stavano acquaroli che vendevano acqua di detta fontana per la città, e specialmente agli abitanti dei contorni della piazza mancanti la maggior parte di buon’ acqua di sorgente. Fu risarcita nel 1755, ed ora trovasi nel massimo stato di deperimento.
In faccia alla fontana del Nettuno furon murate circa il 1574 nella scarpa del palazzo alcune pietre di marmo, sulle quali sono scavate le misure bolognesi della pertica, delle due braccia, del braccio, mezzo braccio, dell’ embrice e del pietrone.
Sotto il pontificato di Giulio III fu fatto l’ornato inferiore della porta del palazzo, al quale li 18 febbraio 1580 fu aggiunto il superiore per collocarvi la statua in bronzo di Gregorio XIIl, posta a suo luogo li 31 ottobre dell’ anno stesso, e scoperta li 16 dicembre susseguente. Pesa libbre 11300. Alessandro Menganti la scolpì, e Anchise Censori la fuse.
Nel 1797 questa statua fu metamorfosata in un S. Petronio sostituendo alla tiara una mitra, e al pastorale pontificio un vescovile.
Da questa ringhiera si pubblicavano i bandi, e si gettava la porchetta il giorno di S. Bartolomeo.
Ogni sera dell’anno all’Ave Maria, dai musici degli Anziani, si faceva un concerto stabilito nei tempi antichi. La musica, o banda degli Anziani, era composta di otto trombetti, di otto tromboni e cornetti, e di un gnacarino.
Il Legato Cesi nel 1581 fece fare le camere dei giudici del Torrone.
Le stanze nuove per i notari del Torrone sopra le stalle del Legato furono costrutte nel 1584.
Nel 1588 si edificò la sala dei ventitrè notari del foro civile, e nel 1660 fu fatta una cappella, ove il Legato Girolamo Farnese celebrò li 11 aprile 1661.
Si è detto che del 1365 vi era un orto, o giardino entro il recinto di questo palazzo, a prova di che trovasi che li 9 novembre 1495 fu ordinato il pagamento di L. 447, 12 a mastro Giacomo Filippi e a mastro Donato da Como, scalpellini, per saldo di colonne, basi e capitelli posti nel giardino della residenza del Legato e de gli Anziani.
Sotto la legazione del cardinal Gaetano si fabbricò la magnifica ed elegante cisterna con disegno del Terribilia.
Un orto di piante medicinali fu già nel monastero di S Salvatore, e un altro nella casa già Gozzadini, poi Pozzi, in Strada Maggiore N. 237. (Così il Fantuzzi T. I, cart. 172 che cita le opere di Gio. Bovino).
Ulisse Aldrovandi, studiosissimo botanico, animato dal desiderio di stabilire un Giardino di semplici degno dell’ Università di Bologna, ricorse al Senato onde aver luogo e mezzi per eseguire il suo progetto. Il senator Camillo Paleotti propose come luogo opportuno il guasto Bentivogli, che fu rigettato.
Li 11 giugno 1568 il senato fissò per tre anni annue L. 1200, e decise di stabilire il suddetto giardino in quello del palazzo. Diede la cura dello stabilimento a Cesare Oddoni e ad Ulisse Aldrovandi, concorrendovi l’adesione del governatore Giovanni Battista Doria nella scelta del luogo. Morì l’Oddoni nel 1571, e l’ Aldrovandi raddoppiò di zelo per portare a compimento il giardino, quando il Legato Gaetano s’invaghì di provveder d’acqua il pubblico palazzo mediante una grandiosissima cisterna per la quale si fissò per luogo più addatto il centro dell’ orto botanico. In quest’ occasione fu trasportato lo stabilimento alla porta di Strada Stefano N.5 in una casa venduta li 15 ottobre 1587 da Cipriano Gatti per L. 11750.
Nel 1600 fu poi ripristinato il giardino dei semplici nel palazzo, formando quattro circondari chiusi da cancelli di ferro e divisi in compartimenti, nel centro dei quali circondari era posta la cisterna.
Il primo custode delle piante esotiche fu il botanico Cesare Oddoni dall’Aquila, l’ ultimo fu il celebre ed eruditissimo dottor Gaetano Monti bolognese. ( Vedi Strada Stefano N. 5).
Li 27 ottobre 1605 fu decretata l’ erezione di quindici botteghe addossate al palazzo nel lato meridionale.
Nel 1606 si costrussero le diciotto dalla parte orientale che furono assegnate agli scaffieri, ossia venditori del pane de’ fornai da scaffa.
Nel 1679 si fabbricarono le venti dalla parte delle Volte dei Pollaroli, finalmente altre se ne stabilirono nel lato occidentale, ora ridotte a sette, delle quali non si conosce l’ epoca della loro origine.
Nel luglio del 1695 fu scoperta la mostra dell’ orologio nel cortile del palazzo, dopo essersi rimodernata la facciata dov’ è collocata con disegno del Monti.
Eugenio IV ordinò che il palazzo già del Comune servisse di residenza al solo Legato e suo ministero, quindi li 22 settembre 1429 gli Anziani e Consoli, il Gonfaloniere di Giustizia e i Riformatori passarono nel palazzo della compagnia dei notari, pagando I’ annuo affitto di L. 750.
Questi magistrati ritornarono nel palazzo pontificio dopo il 1437, ove permanentemente rimasero sino al maggio del 1797.
Le misure dei quattro lati esterni del palazzo del Pubblico rilevate nel 1715 furono le seguenti:
Lato a levante verso la piazza piedi 370.
A mezzodì verso la via delle Asse piedi 340, 6.
A ponente dalla parte della via della piazzola del Carbone piedi 349, 8.
A settentrione dalla parte delle Volte dei Pollaroli piedi 345, 6.
In questo vastissimo palazzo vi alloggiavano tutte le autorità pontificie, e cioè il Legato, il Vice-legato, l’Auditore del Torrone, l’Auditore generale, l’Auditore di Camera, l’Auditore del Vice-legato, i due sotto Auditori criminali, il capitano, il tenente e la compagnia di guardia svizzera assieme alle loro famiglie e persone di servizio. Il Gonfaloniere di giustizia e gll Anziani erano provvisti di comodi alloggiamenti e di ambienti per la pubblica rappresentanza. Il Reggimento e le Assuntarie vi avevano le loro residenze, come anche i Tribuni della plebe. Vi avevano posto i cancellieri del Legato e del Senato, gli uffizi di sanità, dei passaporti, dell’ornato, della chiusa e del canale di Reno, dell’imposta, ecc. La computisteria, la cassa e gli archivi del Senato ed altri suoi dipendenti avevano particolari loro residenze.
Esistevano in questo palazzo due armerie, l’una Pontificia e l’altra del Senato, per fanti, cavalli e per un corpo di artiglieri.
Vi fu luogo per custodire i musei Aldrovandi e Cospi.
Vi erano dodici cappelle, nella maggior parte delle quali si celebrava quotidianamente, e cioè quella del Legato, quella del Vice-legato, la Farnese, quella degli Anziani dedicata alla B. Vergine del Terremuoto, quella dei Cavalleggieri aperta nel secondo cortile l’ anno 1608 sotto il titolo di Sant’ Eduardo Re d’ Inghilterra, poi chiusa per vari anni e riaperta con quello di S. Gio. Battista; quella del magistrato dei Tribuni della plebe intitolata S. Giusta martire, quella dei notari del foro civile dedicata a S. Tommaso d’ Aquino, quella del Torrone, quella dei SS. Giorgio e Sebastiano nel primo cortile per i svizzeri, e l’altra della B. Vergine del Rosario nel loro quartiere. Per ultimo vi erano le stalle per tutte e singole autorità, e per la guardia dei cavalleggieri.
Nel 1542 il Papa mandò una compagnia di 150 svizzeri comandati dal capitano losue di Barolinggera del Cantone cattolico di Ury.
L’assegno mensile era:
Al Capitano scudi 26.
Al Luogotenente scudi 6.
All’ Alfiere scudi 8.
Al Cancelliere scudi 6.
Al giudice scudi 8.
A sei sergenti scudi 2 ciascuno.
Alli quattro suoi uomini bajocchi 50 ciascuno.
Al piffero scudi 2.
A due tamburini scudi 2 ciascuno.
Al prevosto scudi 2.
Ai fanti privati scudi 4 ciascuno.
La guardia svizzera fu rimandata alle sue case nel giugno del 1796 dall’armata francese.
Esisteva pure un’ altra guardia detta dei cavalleggieri, composta di cittadini bolognesi, il cui primo capitano fu nominato in principio di ottobre del 1528 nella persona di Giorgio Lampugnani di Milano. L’ ultimo fu il conte Filippo Marsili eletto tenente colonnello il primo agosto 1780, e colonnello nel dicembre del 1787. Questa guardia aveva un cornetta e un cancelliere, detto poi foriere. Cessò anch’ essa nel giugno del 1796.
Finalmente in questo palazzo vi erano le carceri criminali, alle quali bisognava accedere per l’ unica porta del palazzo, incoveniente al quale è stato provveduto negli ultimi tempi.
Dal 1796 al 1815 il palazzo di governo è andato soggetto ad infiniti cambiamenti di adattamenti e distribuzioni, analoghi ai differenti governi che con tanta rapidità si succedettero l’un l’altro nel suddetto intervallo.
Avanti il 1859 serviva di residenza al cardinal Legato, al Vice-legato, al tribunale criminale, alla polizia, ai tribunali d’appello e pretoriale, agli uffizi del censo, delle acque e strade, della commissione di Reno e del canale di Reno, ecc. Il senatore di Bologna e il consiglio municipale vi teneva le sue sedute e vi aveva i suoi uffici. Le carceri criminali furono sempre conservate nel torrazzo detto del Torrone, sino a che furon trasportate in S. Gio. in Monte, e qui rimasero le carceri per delitti d’opinione o politici.
Resta a dire qualche cosa sulla ringhiera detta degli Anziani, dalla quale, nei tempi dell’ antica repubblica, si dichiaravano le guerre, si pubblicavano le paci, le capitolazioni, le vittorie e le alleanze, e si proclamavano i nuovi dominatori della città e della provincia di Bologna Da questa ringhiera assistevano alla festa di S. Bartolomeo il Legato e il Vice-legato, il Gonfaloniere e gli Anziani; finalmente si esponevano nella medesima i premi della giostra e delle corse dei palj, dei quali stimasi opportuno di darne la storia.
I premi delle corse dei cavalli barbari erano negli antichi tempi presentati ai Difensori dell’ Avere accompagnati dai musici e trombetti degli Anziani, dopo la qual cerimonia erano esposti alla suddetta ringhiera. Quest’ uso continuò fino al 1579.
In seguito furon sostituiti ai Difensori dell’ Avere gli Anziani e consoli. La polizia della strada per dove doveva correre il Palio era affidata al Barigello, il quale accompagnato dal cancelliere e da un caporale della sua guardia percorreva a cavallo per due volte la suddetta strada, dopo di che presentavasi agli Anziani per prendere gli ordini per le mosse; ricevuti questi correva di trotto al sito da dove dovevansi spiccare i cavalli.
Al principio e al fine della corsa vi erano assistenti deputati dagli Anziani, che giudicavano se le mosse e la ferma dei barbari si eran fatte secondo i regolamenti, e ne davan rapporto al magistrato, che finita la corsa rendevasi subito alla sua residenza dove, dietro informazioni precisate, aggiudicava il premio, od ordinava di replicare la corsa il giorno veniente.
Furono nove i Palj che si corsero in Bologna fino alla metà circa del secolo XVIII, e furono i seguenti:
1° Palio di S. Pietro che pare instituito nel 1254 per festeggiare la presa di Cervia fatta dai bolognesi dopo una segnalata vittoria riportata sopra i veneziani. Questa guerra fu cagionata dall’ aver rifiutato i veneziani il consueto sale che fornivano alla città e provincia di Bologna. Nello statuto del 1263 si trova la seguente rubrica : — Il Palio di S. Pietro, che si correva per la strada di S. Gio. in Persiceto, si debba correre dal ponte di Reno fino al serraglio di Porta Stiera, ubi sunt domus Rolandini de Romantiis — Nel 1547 si cominciò a correre per Galliera il giorno stesso di San Pietro primo protettore di Bologna. Le mosse si davano fuori della città, la corsa passava davanti la Cattedrale, e terminava in Piazza Maggiore dal palazzo dell’ arte dei notari. Il premio era di due pezze intere di buon velluto rosso del prezzo di L. 50 di bolognini, di un’asta alla quale si appendevano le due pezze di velluto, e di un gallo. Alla corsa di questo Palio non erano ammesse le cavalle. La spesa era addossata al rettore del ponte di Reno.
Sotto la data delli 10 febbraio 1440 si trova il seguente ordine: — Si paghi ad Orazio pittore, per pittura, banda, taffetà, oro, argento ed altre cose necessarie per ornamento del Palio di S. Pietro, L. 22, 10; a Cristoforo Ambrosi per braccia 22 di zennanino cremisi L. 221, 15. Totale L. 244, 5. Nei tempi a noi vicini si spendevano L. 196.
Li 11 febbraio 1462 si ordinò che per il Palio di S. Pietro si spendessero sole L. 140. Dalle date di queste due ordinazioni fatte in febbraio potrebbesi sospettare che il palio si corresse nel detto mese.
2° Palio di S. Bartolomeo, detto del Ronzino.
1335, 9 giugno. Ronzino, ossia cavallo liardo rosso. Rogito di Mino di Chesino di Lorenzo Parini.
Questo Palio sembra cominciato nel 1249, la cui corsa aveva principio dal ponte di Reno fuori di porta S. Felice e terminava alle case dei Romanzi presso la Seliciata di S. Francesco.
Lo statuto del 1263 ordina che la corsa abbia cominciamento dal ponte maggiore di Savena fuori di porta Strada Maggiore, e termine al trivio di Porta Ravegnana. In seguito fu prolungata fino alla via Fieno e Paglia, e cioè fino alle carceri del Torrone. I premi erano un ronzino e uno sparaviere, poi nel 1280 fu aggiunta una porchetta, e dopo anche due cani bracchi. Il rettore dell’ ospedale dell’ Idìce pagava L. 40 per le spese di questa corsa.
3° Palio di S. Ruffillo. Era da quattro anni che Bernabò Visconti tormentava con continua guerra i bolognesi. Li 20 giugno 1361, giorno di S. Silverio, essendo l’esercito nemico trincierato alle rive di Savena in un campo di Palamidesse Rossi, a due miglia fuori di porta Santo Stefano, fu attaccato e distrutto dai Bolognesi nel dopo pranzo di detto giorno. In questo fatto d’ armi rimase morto Fernando pretore di Bologna, che onorevolmente fu sepolto in S. Francesco, e fu ferito Gomezio Albornozio nipote del cardinal Legato. Questa battaglia fu fatta dipingere da Francesca del fu Bernabò di Polenta, moglie di Alberto Gallucci, nella cappella dei Bottrigari posta a mano sinistra fuori della chiesa di S. Francesco. Per questo fatto d’ armi s’ instituì il Palio di S. Ruffillo, che in origine si corse dalla Croce di Camaldoli fuori di porta Santo Stefano fino alla piazza di Santo Stefano. In seguito le mosse si davano dalla casa di Camillo Duglioli fuori della predetta porta continuado la corsa in città fino alla via del Luzzo, poi voltando per le Chiavature terminava in piazza dalla casa dei Notari.
Il premio era di due pezze di velluto vergato del prezzo di L. 50 di bolognini, nel cui penone (banderuola) era dipinto un S. Ruffillo; più uno stendardo con uno scudo, o tavolaccio, sul quale eran dipinte le armi della libertà; inoltre uno stocco dorato, un paio di manopole, o guanti di ferro, e un paio di speroni dorati.
Questi premi furon poi limitati ad una pezza di velluto morello e ad uno stocco.
Li 8 luglio 1440 fu fatto il seguente mandato: — Per il Palio di S. Ruffillo si paghino L. 40, 1, per il tanino alessandrino con figure e per la bandriola di detto palio, per spesa e fattura L. 175, totale L. 215, 1. —
Li 11 febbraio 1462 si ordinò che la spesa del palio di S. Ruffillo, compresa la banderuola di taffetà, non oltrepassasse le L. 140.
4° Palio di S. Petronio. Alcuni han scritto che questo palio si instituisse nel 1141 per l’ invenzione del corpo di S. Petronio, ma non è vero. Li 21 settembre 1396 gli Anziani, i Consoli, il Gonfaloniere di giustizia e i Collegi decretarono che ogni anno si dovesse correre un palio per la festa di S. Petronio per la cerchia e borgo di Galliera fino alla piazza, e ne fu fissata la spesa in bolognini 50 d’ oro da pagarsi dai capitani del primo e secondo semestre.
Il primo mandato che sia notato negli atti dei Riformatori per questo palio è delli 2 ottobre 1452, forse perchè in quest’anno cessò di stare a carico dei due capitani.
Li 11 febbraio 1462 fu decretato che il palio di S. Petronio non dovesse costare più di L. 230.
Fu poi cambiata la corsa ordinando che le mosse si dessero all’ osteria del Rosso fuori di porta S. Felice, di qua dalle fornaci, e la ferma fosse dal palazzo dei notari. Il premio era una pezza di velluto cremisi e una borsa dello stesso drappo, il di cui costo complessivo era di L. 207 in epoca a noi vicina.
5° Palio di Giulio II, ordinato per ricordare l’ ingresso in Bologna di questo pontefice seguito li 11 novembre 1506 dopo la cacciata dei Bentivogli. Si diceva volgarmente palio di S. Martino, perchè correvasi nel giorno di questo santo dalla Croce dei Crosati fuori di porta Strada Maggiore fino alla via Fieno e Paglia, ossia al Torrone. Il premio fu dapprima un drappo d’ oro, poi commutato in una pezza di velluto cremisi.
6° Palio di Gregorio XIII stabilito per l’ esaltazione di questo nostro concittadino al sommo pontificato li 13 maggio 1572. Si correva dalla porta di Galliera fino alla Piazza Maggiore. Il vincitore era premiato di un drappo di velluto cremisi.
7° Palio d’Innocenzo IX bolognese eletto pontefice li 28 ottobre 1591, che correvasi dalla porta di S. Felice fino alla Piazza Maggiore. Era il premio di questo simile a quello di Gregorio XIII.
8° Palio dei Paggi. Li 30 novembre 1598 Clemente VIII fece il suo solenne ingresso per la porta di Galliera dopo aver preso possesso della città e ducato di Ferrara a nome della chiesa. Regalò egli scudi mille ai paggi che lo servirono in tempo del suo soggiorno in Bologna. Quei nobili giovinetti depositarono la somma nella cassa del Senato perchè colle rendite si corresse un palio il giorno di Sant’Andrea. Il premio era una tela d’ argentio contornata dagli stemmi delle famiglie dei paggi. La corsa facevasi dalla porta di Galliera fino alla Piazza Maggiore.
9° Palio di Gregorio XV fatto papa li 8 febbraio 1621. Correvasi per strada Saragozza li 9 febbraio, e dicevasi palio di Sant’Appolonia. Le mosse si davano alla porta della città, e la ferma doveva essere in via Val d’ Avesa finchè aperta la via Urbana fu poi stabilita in S. Mamolo dalle case dei Marsili. Il cavallo vincitore era regalato di una pezza di velluto cremesi.
10° Palio di Benedetto XIV innalzato al pontificato li 17 agosto 1740. Li 10 febbraio 1741 fu decretata questa corsa che cominciava dalla porta di Strada Santo Stefano fino alla piazza della Mercanzia, e si correva li 21 agosto giorno della sua coronazione. Un pezza di sedici braccia di velluto cremisi era il premio destinato al vincitore, pel quale ne’ tempi a noi vicini si spendevano L. 229.
Benedetto XIV decretò la soppressione dei Palj di S. Ruffillo, di Giulio II, di Gregorio XIlI, d’Innocenzo IX, dei Paggi e di Gregorio XV, applicando la spesa annua di L. 1198, che importavano le dette corse, a sollievo della Camera di Bologna.
Rimasero i palii di S. Pietro, di S. Petronio e di Benedetto XIV fino al 1796, non contandosi quello di S. Bartolomeo andato in disuso da moltissimi anni.
Dopo l’epoca predetta furon soppressi quelli ancora di S. Pietro e di Benedetto XIV, e conservato soltanto quello di S. Petronio che si correva dalla Carità in Strada S. Felice fino alla Masone in Strada Maggiore, col premio di scudi 90 e una bandiera al primo cavallo vincitore, e ciò a spese della Comune.